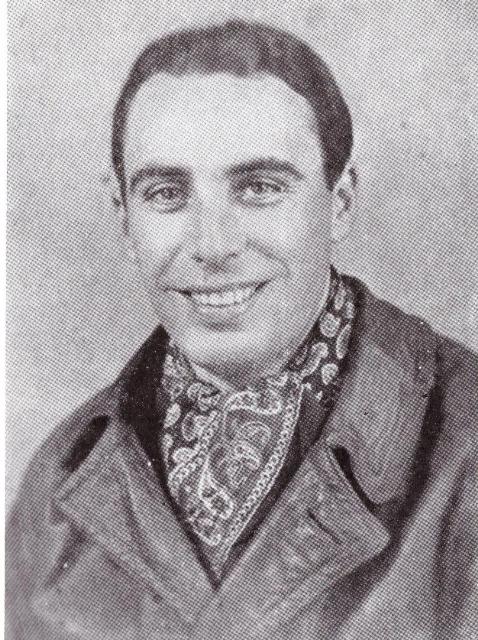Questa è la storia di Emanuela Lina Meiffret, partigiana e letterata sanremese, è il racconto della vita di una donna coraggiosa, dal forte impegno civile, dagli ideali profondi e radicati, rimasta troppo a lungo nell’ombra. Dopo essere stata una presenza politica attiva nella lotta di liberazione dal nazifascismo a Sanremo nei mesi antecedenti e successivi all’8 settembre del 1943, viene arrestata nel febbraio del ’44 e poi deportata in Germania, vivendo la tragedia dei campi di concentramento. Attraverso gli articoli sui giornali della Resistenza sanremese, i preziosi documenti dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia, i libri sulla Resistenza, le memorie di antiche amicizie, gli Archivi privati, abbiamo cercato di raccontare – con coinvolgimento e continua sorpresa – la complessità della figura umana di Lina. Che è personalità poliedrica, con studi in Svizzera e alla Sorbona, poliglotta, poeta e traduttrice, amica di personalità di spicco del Ponente ligure (e non solo!), tra Sanremo e Bordighera, come Italo Calvino, Guido Hess Seborga, Renato Brunati, Beppe Porcheddu e tanti altri. Ora sappiamo che dietro la riservatezza della partigiana Lina Meiffret si celano, accanto alle vicende drammatiche del Novecento, uno spessore culturale, una miniera di relazioni ed intrecci culturali che fanno di questa storia un’esperienza unica che abbiamo sentito la necessità di condividere e rendere nota. In questo libro, oltre ad essere riportate le testimonianze storiche e giornalistiche insieme alle immagini di documenti originali, vengono pubblicate le opere per la gran parte inedite (poesie, lettere, racconti, traduzioni) di Lina Meiffret. Attraverso questo prezioso lavoro di ricerca e svelamento, vogliamo rendere omaggio soprattutto ad una donna che ha saputo essere protagonista e partecipe delle cose del mondo e della Storia e che riemerge oggi più attuale che mai, sottile interprete dell’umanità e della personalità di quegli uomini e quelle donne con cui ha condiviso valori ed ideali.
[…] Le vicende che riguardano da vicino la Meiffret hanno inizio ben prima dell’8 settembre 1943. Verosimilmente Lina, che studia a Parigi alla Sorbonne, nei mesi immediatamente precedenti all’invasione tedesca della Francia, è costretta a lasciare la Francia e a tornare a Sanremo dove entra in contatto con vari gruppi facenti parte del movimento antifascista locale, il quale operava nella zona sia attraverso la sezione del P.C.I., sia nella più assoluta
clandestinità in diversi gruppi e sottogruppi più o meno organizzati, legati dal vincolo di un ideale politico comune, dal desiderio di riconquistare la libertà e opporsi agli oppressori, già dalla fine degli anni Trenta <13. In questo primo periodo Lina si muove tra Sanremo e Bordighera <14, dove del resto già era presente un gruppo di letterati e artisti antifascisti, sorto autonomamente intorno al 1939 (e poi confluito dopo la guerra nel partito socialista), che faceva capo a Guido Hess Seborga, il quale raccolse inizialmente intorno a sé, oltre a Lina, i suoi giovani amici Renato Brunati e Beppe Porcheddu, che qui si trasferì proprio nel 1939. Si legge nel Documento Porcheddu: «[…] La propaganda antifascista e antitedesca fu praticata nella zona di Bordighera da Renato Brunati e da me in un contempo indipendentemente, senza che nemmeno ci conoscessimo: ma nel 1940 ci incontrammo e d’impulso associammo i nostri ideali e le nostre azioni, legati come ci trovammo subito anche da interessi intellettuali e artistici. […]». Questo gruppo era in contatto con degli amici di Torino che condividevano gli stessi ideali, tra cui spiccano i nomi, che ricorrono più volte nella corrispondenza intercorsa tra Lina e Guido, di Giorgio Diena, Umberto Mastroianni, Vincenzo Ciaffi, Carlo Muffo, Oscar Navarro e altri, coadiuvati da Alba Galleano, anch’ella di Bordighera che poi sposerà Hess nel ’39. Gli esponenti di questo gruppo torinese, che svolse durante il Fascismo soprattutto attività di propaganda e di collegamento tra le due regioni, diffondendo i libri «proibiti», confluirono poi, dopo l’8 settembre, nelle formazioni partigiane di Giustizia e Libertà e Matteotti <15.
Sono documentati in questi anni precedenti l’Armistizio anche alcuni soggiorni di Lina nelle amate Val Gardena e Val Badia. Un caffè di Rapallo, sulla costa ligure di Levante, in quegli anni era il punto di incontro di molti intellettuali, fra cui Hess, Lina stessa, Pound (il poeta e scrittore statunitense che si trasferì proprio in questa località dove risiedette quasi stabilmente dal 1925 al 1945 e di cui Lina tradusse i suoi Cantos) e il futuro comandante partigiano Giorgio Buridan, che farà poi parte del gruppo degli intellettuali di Torino, con cui Lina ebbe un grande rapporto di amicizia, testimoniato principalmente dalle poesie a lei dedicate, oltre che da una fitta corrispondenza e da numerose traduzioni a lei affidate <16.
Lina, da marxista convinta, è iscritta alla sezione del P.C.I. di Sanremo dove primeggia la Sezione Giovanile, ricca di elementi coraggiosi e dinamici, tra cui vengono reclutati coloro che partiranno per la guerra di Spagna, per il
cosiddetto «Soccorso Rosso», come Renato Brunati. Inoltre, partecipa attivamente alla lotta antifascista, attività consistente principalmente, nel periodo che va dalla caduta del regime all’Armistizio, nel convogliare la gioventù del circondario entro quelle formazioni partigiane che cominciano a costituirsi sulle colline e sui monti alle spalle di Sanremo. Qui, a Baiardo Lina ha una proprietà che mette a disposizione della banda e che rappresenterà il quartier generale in altura; sulla costa, invece, il luogo di ritrovo e smistamento è rappresentato dalla villa Llo di Mare che Porcheddu aveva affittato ad Arziglia (Bordighera), lungo la via Aurelia; Renato ha invece una casa alla Madonna
della Ruota, sempre a Bordighera.
Si ipotizza in un documento pubblicato chiamato per comodità “Pratica Meiffret” (una sorta di relazione sull’attività della Meiffret redatta in data 11/3/1946, la cui attendibilità di alcuni contenuti è comunque discutibile), che Lina avesse dei contatti con ufficiali del servizio francese e che per questo si recasse spesso in Francia, mentre probabilmente stava svolgendo un’attività di organizzazione del fronte della Resistenza spagnola, come viene in effetti
confermato in una lettera del 9 maggio del 1946 di Giorgio Buridan, in cui compaiono del resto altri nomi presenti sul documento. Vi si legge: «[…] Cara amica, dammi tue notizie, su di morale…non vagheggiare a idealistici spagnolismi e lavora invece […]»
Certamente Lina si recò più volte in Francia per motivi culturali: lo stesso Hess le procurò un documento, datato 8 febbraio 1946, dell’Unione culturale di Torino; sicuramente conosceva ed era in contatto con Vualch (nel documento
del ’46) o Walch (nella lettera di Buridan) di Nizza, probabilmente un editore, che aveva ricevuto da Buridan il suo diario partigiano di cui non aveva, ancora nel maggio del 1946, dato un riscontro all’autore. È certa, invece, la sua amicizia con Philippe Garigue <17, altro nome presente nel documento, come risulta evidente da un racconto che lui le avrebbe affidato di tradurre, conservato tra le sue carte, dal titolo “Antonio”; è altresì certo il rapporto di
collaborazione per scopi di lavoro tra Lina e Garigue, come dimostrerebbe il documento dal titolo evocativo “Appunti per Lina”, una sorta di memorandum-progetto, scritto da Guido Hess, in cui si prospetta la possibilità di «chiedere al cap. Garigue se conosce bene l’alleato da cui dipende il permesso per nuovi giornali. In caso positivo, chiedere a Garigue di farmi un biglietto di presentazione. Se Garigue deve tornare a Torino, dagli il mio indirizzo, o scrivermi per dirmi dove posso andare per rintracciarlo». (Senza data, ma con firma «Guido Hess»).
Anche Bruna De Marchi, citata nel documento, con cui Lina si sarebbe presentata al CLN di Bordighera, è una sua amica: si tratta della signora presso la quale la Meiffret risiedeva a Villa Monteverde, prova ne sia una busta di lettera, inviata da Roma dal futuro marito di Lina, Mario Scudieri, nel 1947.
Renato Brunati
Renato Brunati <18, figlio di Giuseppe Brunati, un ufficiale fascista, e di Margherita Burki, nasce a Venezia l’8 febbraio del 1903, ma, dopo essersi spostato in varie città italiane e estere, sceglie come residenza la cittadina di
Bordighera nel Ponente ligure, in cui, come già detto, si raccolgono alla fine degli anni Trenta alcuni intellettuali antifascisti. Ross così lo descrive: «[…] He was a generous, warm-hearted man. An intellectual with a love of literature and poetry. In his present political role he jokingly likened himself to Byron. […]» Letterato, filosofo e poeta, Lina affermava che Renato era stato uno scrittore molto fecondo. Di lui è riuscita a conservare alcune poesie inedite che, rappresentando probabilmente gli unici documenti letterari che ci rimangono di questo eroe della Resistenza, acquistano un valore ancora maggiore tra le testimonianze scritte della lotta partigiana nel Ponente ligure.
«E pure morì sotto il martirio nazista l’animatore di una delle prime bande a Baiardo: Brunati, il partigiano poeta». Così lo ricorda infatti Italo Calvino nel suo “Ricordo dei partigiani vivi e morti”. Appartenente alla II Divisione Felice Cascione, V Brigata Nuvoloni di Imperia, propagandista e organizzatore delle bande armate bordigotte collegate a Sanremo e, dopo l’8 settembre, elemento di spicco della banda che opera a Baiardo con Lina Meiffret. Renato viene arrestato due volte e sempre con Lina <19: la prima poco dopo l’8 settembre 1943, per propaganda antifascista, ma viene quasi subito rilasciato <20; il secondo arresto, definitivo, ha luogo a Sanremo, allorché Brunati viene fermato e trovato in possesso di volantini e documenti compromettenti <21. Di questi fatti ci parla M. Ross, nel suo libro: il primo arresto avviene per possesso e diffusione di materiale sovversivo verosimilmente nel dicembre 1943, con rilascio subito dopo le festività natalizie per mancanza di prove. Il secondo arresto, definitivo, avviene dopo qualche giorno, il 6 gennaio 1944, come risulta del resto dal documento ANPI, a Sanremo, allorché Brunati viene fermato e trovato in possesso di volantini e documenti compromettenti <22, ma Ross è il solo a parlare del doppio arresto dei due compagni in questa data. Per quanto affermato da altri studiosi, si veda Gandolfo, Sanremo in guerra cit., p. 138.20: la prima poco dopo l’8 settembre 1943, per propaganda antifascista, ma viene quasi subito rilasciato.
Durante la guerra Brunati era stato ufficiale nella GAF (Guardia alla frontiera) a Mentone. Come già accennato, aveva quindi fatto parte, come volontario, del Soccorso Rosso, esperienza che lo aveva condotto a militare nella Brigata Internazionale in Spagna. A Bordighera, dove ha una casa alla Madonna della Ruota, Renato fa parte di una ristretta cerchia di intellettuali, tra i quali, oltre a Lina e al pittore e illustratore Beppe Porcheddu, va ricordato il suo grande amico Guido Hess Seborga. Guido avrà un lungo rapporto di amicizia con questo giovane eroe che si interromperà con la sua tragica fucilazione al Turchino. Hess gli resterà fedele nell’affetto: una eco di quanto la morte di Renato abbia profondamente segnato gli animi di tutti coloro che lo avevano conosciuto in quegli anni resistenziali si può concretamente leggere negli scritti che molti di loro gli rivolgeranno. A Brunati Hess dedica il suo primo romanzo “L’uomo di Camporosso”, uscito nel 1948, e lo ricorda nel suo secondo romanzo sulla Resistenza del Ponente ligure pubblicato nel 1949 e intitolato “Il figlio di Caino”, in cui il protagonista, capo ammirato e indiscusso di un gruppo di partigiani riunitisi in una banda che si nasconde sul Monte Nero, tra Sanremo e Bordighera, porta il nome decisamente evocativo di Renato Bruni.
[NOTE]
13 Cfr. Gandolfo, Sanremo in guerra cit., pp. 129 ss.
14 Nel 1941 è sicuramente a Bordighera, come dimostra un suo appunto su di un foglio di quaderno (Archivio Giacometti Loiacono); nel luglio del 1943 è sempre a Bordighera, come si deduce dalla lettera indirizzata ad Hess con firma congiunta di Renato (Brunati) e Lina (Archivio Laura Hess); nella «pratica Meiffret», con data 11/3/1946, si legge «residente a Bordighera».
15 R. Zangrandi, op. cit.
16 Su Giorgio Buridan è uscito un volume curato da Maria Silvia Caffari, Fatti e persone nella mia vita, Nerosubianco ed. 2021, in cui il rapporto con Lina viene limitato solo alla sua attività di «traduttrice… una francese che frequentai per un certo periodo e insieme discutemmo sulla difficilissima traduzione dei Cantos», pp. 75-76.
17 Il capitano Philippe Garigue fu scelto nel 1945 dagli Alleati per condurre le trattative di pace con i francesi di De Gaulle che entrarono a Ventimiglia rivendicando piena libertà di azione nei confronti dell’Italia con la quale si consideravano ancora in stato di guerra (la Francia non aveva firmato l’Armistizio dell’8 settembre). Grazie alla mediazione di Garigue i francesi evacuarono Ventimiglia l’11 luglio del 1945. Al capitano Garigue per queste sue azioni fu conferita la cittadinanza onoraria di Ventimiglia. Si veda R. Villa, La difficile missione del cap. Garigue, nella Ventimiglia del 1945, occupata dai francesi, da La Voce Intemelia, anno XLIV, n. 10. Ottobre 1989.
18 Per la bibliografia su Brunati si veda: http://www.bordighera.net (articolo di V. Moschetti del 24 febbraio 2014 con riferimento al saggio di P. Revelli, La seconda guerra mondiale nell’estremo Ponente ligure); Strato, La Resistenza in provincia di Imperia cit., pp. 241, 247 e nota 16, 302 e nota 45; L’epopea dell’esercito scalzo cit., pp. 43-44, 47-48; http://www.straginazifasciste.it (Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia), s.v. Passo del Turchino; Mela, Aspettando aprile cit., pp. 35-36, in cui lo si definisce «studioso di problemi filosofici, specialmente riguardanti l’educazione del fanciullo»); Gandolfo, Sanremo in guerra cit., pp. 137 ss.. Su Renato si legga inoltre il ricordo commosso ed appassionato che di questi scrive G.B. Calvini in L’epopea dell’esercito scalzo cit., pp. 47-48; in Biga-Iebole, Storia della Resistenza imperiese cit. pp. 192 ss. Renato viene definito a ragione come «la figura più ardimentosa e romantica della lotta partigiana nella zona di Sanremo». Per una sua descrizione fisica e caratteriale, cfr. Ross, From Liguria with Love cit., pp. 157 ss., il quale definisce Lina e Renato «both idealists and dreamers»; F. Mocci (con il contributo di D. Canavese di Ventimiglia), Il capitano Gino Punzi, alpino e partigiano, Alzani ed., Pinerolo (TO), 2019, (Documento Porcheddu).
19 Si veda in Ross, From Liguria with Love cit., pp. 163-64 e ss., il racconto del doppio arresto di Lina e Renato: il primo, come si può desumere dal testo, avviene per possesso e diffusione di materiale sovversivo verosimilmente nel dicembre 1943, con rilascio subito dopo le festività natalizie (altrove si legge il 22 dicembre); il secondo dopo qualche giorno, se si deve credere alla data del 6 gennaio 1944 riportata nel documento dell’ANPI. Ross è comunque il solo a parlare del doppio arresto dei due compagni. Per quanto affermato da altri studiosi, si veda Gandolfo, Sanremo in guerra cit., p. 138.
20 Cfr. Strato, La Resistenza in provincia di Imperia cit., p. 247 fa riferimento ad un arresto subito dopo l’8 settembre 1943: con tutta probabilità si tratta del fermo di cui parla Ross, avvenuto tra fine novembre e dicembre, quando Renato si trovava nella sua casa di Bordighera con Lina (mentre nascondeva i due inglesi) di cui parla Ross, cfr. nota precedente.
21 Cfr. Mela, Aspettando aprile cit. p. 36. In Gandolfo, Sanremo in guerra cit., p. 138 si riferisce invece che Renato era in missione a Sanremo; similare il racconto di Ross, From Liguria with Love cit., p. 168 che, però, parla di questioni urgenti che sia Lina sia Renato avevano da sbrigare a Sanremo.
22 Cfr. Mela, Aspettando aprile cit. p. 36. In Gandolfo, Sanremo in guerra cit., p. 138 si riferisce invece che Renato era in missione a Sanremo; similare il racconto di Ross, From Liguria with Love cit., p. 168 che, però, parla di questioni urgenti che sia Lina sia Renato avevano da sbrigare a Sanremo.
Daniela Cassini – Sarah Clarke, Lina. Partigiana e letterata, amica del giovane Calvino. Lettere, poesie e scritti inediti di Lina Meiffret, Isrecim, Fusta editore, 2022
Tag: 1943
A San Michele si può dire che ogni casa è inabitabile
Dopo l’8 settembre 1943, giorno dell’armistizio, ad Olivetta San Michele era rimasto solo un gruppo di carabinieri, mentre i restanti militari del Regio Esercito avevano cercato in ogni modo di sfuggire alla cattura da parte dei soldati germanici. Data l’importanza del collegamento viario con il Piemonte, la Val Roia conosce sin da subito l’attenta vigilanza dell’occupante tedesco, che tuttavia per mesi non si traduce in un presidio militare stabile e consistente nei centri della bassa valle. La situazione si fa ben più critica quando, con lo sbarco alleato in Provenza nell’agosto 1944, i tedeschi in ritirata stabiliscono una linea di difesa sulla dorsale delle Alpi Marittime, facendo della Val Roia un’immediata retrovia del fronte. E’ allora che il nemico occupa in forze il comune per trasformarlo, al pari di Airole, in un caposaldo del fronte, per cui ivi rimarrà fino alla Liberazione, spargendovi il terrore con rastrellamenti e saccheggi. Per la gente della bassa Val Roia inizia così un tragico calvario. Come le popolazioni di Airole, Collabassa e Piena (quest’ultima a quel tempo frazione di Olivetta, ora invece francese), anche gli abitanti di Olivetta sono fatti sgomberare dai tedeschi ed avviati verso Tenda ed ancora più a nord, in gran numero fino a Torino, con treni o con atri mezzi, senza viveri, esposti alle intemperie; molte persone sono ammalate; i più sofferenti sono i bambini. La poca gente che riesce a rimanere in paese è sempre sotto la minaccia della frusta tedesca.
Come ad Airole, anche qui, data l’estrema drammaticità della situazione, non si costituì mai un CLN, ma taluni antifascisti – tra cui, per indicarne uno, Bruno Muratorio <679 – si mossero comunque, riuscendo col tempo a collegarsi con i partigiani della V Brigata “Luigi Nuvoloni”, che operava tra la Valle Argentina e la frontiera. Degli abitanti del Comune, sono stati riconosciuti partigiani combattenti i cittadini: Agostino Cotta (Michele), deceduto il 20 luglio 1945 a Verrino Olivetta; Pietro Gavini (Barin), fucilato il 12 agosto 1944 a Sospel; e Dante Limon (Spezia). Appartenevano alle Brigate IV e V della II Divisione d’assalto Garibaldi “F. Cascione”. <680
Durante l’occupazione di Olivetta San Michele i tedeschi fucilarono i civili Carlo Gastaldi, Oreste Gastaldi e Costantino Ricci. <681
Una nota d’ambiente del periodo di occupazione tedesca a Olivetta è delineata alle pagine 61-62 del volume “Ricordi di guerra”. <682
Pesantissimi i danni inflitti agli abitanti del piccolo comune, se solo si pensa che a causa di incursioni aeree alleate risultarono distrutti 180 fabbricati, mentre altri 38 finirono devastati a seguito di operazioni nazifasciste. <683 Un problema non di poco conto, tra i molti e assillanti di allora, per la nuova amministrazione democratica in carica negli anni 1945-1946, sindaco Giulio Iperti e assessori Armando Limon, Luigi Rey, Lorenzo Trucchi e Umberto Trucchi. <684
Per avere un quadro vivido della situazione creatasi a Olivetta per effetto dell’occupazione tedesca, ci rifacciamo a quanto scritto mesi dopo la Liberazione da Don Ermenegildo Moro: “Il paese è gravemente colpito dalla guerra: vi sono moltissime case di abitazione inservibili. A San Michele si può dire che ogni casa è inabitabile, perché tutte bruciate e distrutte eccezion fatta della stazione e della casa comunale. La popolazione è indigente di ogni cosa, perché tutto è stato asportato oppure incendiato e distrutto sul posto. Sarà un problema grave provvedere gli indumenti e la biancheria per fronteggiare l’inverno. Di questo nulla è rimasto e se un po’ è stato ritrovato è inservibile ed in pessimo stato. Un altro problema grave è quello del latte per i bambini. Nessuna mucca e pochissime capre, assolutamente insufficienti alla bisogna. Occorrerebbe ottenere una dotazione di latte condensato. Le condizioni sopra descritte sono ancora aggravate dal fatto che non è ancora possibile il transito, per la rottura dei ponti, e questo dopo più di tre mesi dalla cessazione delle ostilità. Nessuno provvede e questo inverno sarà terribile per vettovagliarci e per ripararci dalle intemperie…”. <685
[NOTE]
679 Bruno Muratorio riuscì a fuggire dal campo di concentramento tedesco di Monza il 2 febbraio 1945 e, dopo varie peripezie, si rifugiò a Torino fino alla Liberazione con tanti suoi conterranei (ISRECIM, Archivio, Sezione II, cartella L 75).
680 ISRECIM, Archivio, Sezione II, cartella R2.
681 ISRECIM, Archivio, Sezione II, cartella 111; lettera del sindaco di Olivetta datata 12 gennaio 1981.
682 Ricordi di Guerra (Ventimiglia 1940-1945), s.l. [s.t. Pinerolo], Comune di Ventimiglia e Dopolavoro Ferroviario, 1995.
683 ISRECIM, Archivio, Sezione II, cartella 111; lettera del sindaco di Olivetta datata 21 settembre 1945. Vedasi pure ISRECIM, Archivio, Sezione II, cartella L 37.
684 Ibidem, lettera datata 24 marzo 1998.
685 Don Nino Allaria Olivieri, “I testimoni raccontano”, cit., pag 59 e sgg. Il lavoro continua con il capitolo ‘Piena e Libri'”, dove si evidenzia la tristezza della popolazione locale costretta ad assumere la cittadinanza francese.
Francesco Biga e Ferruccio Iebole (a cura di Vittorio Detassis), Storia della Resistenza Imperiese (I^ Zona Liguria) – vol. V, Ed. Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia, 2016, pp. 230-231
[3 settembre 1944]
[…] “Nettu” [Ernesto Corradi], che fino a quel momento si era mantenuto nascosto, esce allo scoperto con il corpo proteso in avanti, guarda ancora per un istante il viadotto sospeso nel vuoto sul Roia, poi, deciso, parte correndo e, in pochi secondi, raggiunge l’altra sponda; per alcuni istanti rimaniamo indecisi, ma, mentre sulla strada persiste ancora il silenzio, anche noi partiamo saltando di corsa sulle traversine dei binari e riusciamo tutti a raggiungere il nostro capobanda.
Un tratto di galleria che copre quella strada percorsa dal nemico facilita il nostro passaggio, infatti proprio mentre ci troviamo sulla sua sommità, sotto di noi transita un’autoambulanza scortata da un camion tedesco.
Ci allontaniamo in fretta per raggiungere la cima di una collina, intanto sulla strada il traffico degli automezzi militari continua inarrestabile.
Superato il grande ostacolo del Roia, ci dirigiamo verso il paese di Collabassa [Frazione di Airole IM)]; sul sentiero, fra alberi di pino, incontriamo un giovane di Olivetta San Michele e lo convinciamo a seguirci; il suo nome di battaglia sarà “Pineta”, proprio a ricordo del luogo in cui l’abbiamo incontrato.
[…] “Pineta”, già combattente nei battaglioni d’assalto a Tobruch, aveva sofferto la guerra e il suo unico desiderio era di vederla finita.
I rimanenti sei, di cui io facevo parte, erano tutti ragazzi sotto i vent’anni, nati e cresciuti in epoca fascista; non avevano mai conosciuto la vera libertà.
[…] Riprendendo la descrizione delle nostre avventure, dopo aver varcato la frontiera cui accennavo prima, scendiamo lentamente con cautela verso Castellar, un piccolo paese sopra Mentone […]
Giorgio Lavagna (Tigre), Dall’Arroscia alla Provenza. Fazzoletti Garibaldini nella Resistenza, IsrecIm, ed. Cav. A. Dominici, Oneglia Imperia, 1982
Si è qui sopra riprodotto un minimo stralcio delle avventure occorse ad un gruppo di partigiani che, debitamente autorizzati dai comandi garibaldini imperiesi, cercavano di unirsi alle forze alleate, a quella data ormai giunte alla frontiera italo-francese.
Arrivati oltre confine Lavagna ed i suoi compagni, compresi quelli trovati cammin facendo, vennero arruolati nella FSSF, First Special Service Force (chiamata anche The Devil’s Brigade, The Black Devils, The Black Devils’ Brigade, Freddie’s Freighters), reparto d’elite statunitense-canadese di commando, impiegato anche nella Operazione Dragoon nel sud della Francia, tuttavia sciolto nel dicembre 1944; a questa data, per non farsi internare, questi garibaldini furono costretti ad immatricolarsi nel 21/XV Bataillon Volontaires Etrangérs francese.
Adriano Maini
Estate-autunno 1944 – Sfollamento a San Michele. Altri ricordi ferroviari
Dopo il primo bombardamento notturno e dopo due o tre notti passate nella galleria-rifugio di via San Secondo, si pensa di sfollare, anche perché l’alloggio è stato un po’ danneggiato. La scelta di molti ventimigliesi cade su Airole e San Michele, per via della facile comunicazione ferroviaria con Ventimiglia, dove la vita e il lavoro continuano.
[…] Trovata sistemazione a San Michele, vi portiamo, sempre col treno, un po’ di masserizie (letti, materassi, vestiario, oggetti di cucina). Si spera sempre che gli alleati “facciano presto”, specialmente dopo lo sbarco in Provenza
dell’agosto. Ma proprio quest’ultima operazione sarà la generatrice delle più gravi vicende.
Il trenino per un po’ di tempo fa il suo bravo dovere tra Ventimiglia e Piena, poi sposta il suo capolinea ventimigliese in zona Peglia (non ricordo più se per interruzione del ponte sul Roia o per non esporlo a mitragliamenti in stazione).
Una sera (ancora chiaro), quasi in arrivo a Bevera, sentiamo e vediamo volteggiare sopra di noi un paio di “caccia”. Il treno si ferma, tutti giù di corsa verso il paese, a ripararci quanto possibile. Non succede nulla, quei piloti hanno avuto coscienza. Si riparte a notte fatta. Pochi giorni dopo il servizio ferroviario cessa di funzionare.
A Ventimiglia la situazione si aggrava. Bombardamenti, mitragliamenti, incursioni fulminee. Mancato il treno, si utilizza qualsiasi mezzo, biciclette, carri a trazione animale, perfino un carrello del Servizio Lavori (cioè uno di quei carrelli, non a motore, che circolano sui binari per la manutenzione), naturalmente usato una sola volta in discesa, ché spingerlo in salita sarebbe stato impossibile; infine si va anche a piedi.
Un mattino, transitando da Airole (meglio, sotto Airole, sulla statale), trovo un carro, trainato da un mulo, carico di giovani dell’esercito della R.S.I., che dalla loro caserma (il fabbricato mi pare ci sia ancora) si apprestano a scendere verso Ventimiglia. Tra essi alcuni amici che avevano fatto quella scelta. Mi invitano a salire ed io accetto di buon grado anche se, cammin facendo, “stringo” un po’ all’idea di trovarmi in mezzo a un agguato di partigiani.
Come si intuisce, è ormai impossibile percorrere tutti i giorni il tragitto San Michele-Ventimiglia. Però bisogna andare perché si rischia di essere considerati assenti ingiustificati dal lavoro. Allora ci si ferma qualche notte a Ventimiglia, poi si va su e si ridiscende e così via […]
Renato Pastorino, “Flashes” di guerra 1940-1945 in Renzo Villa e Danilo Gnech (a cura di), Ventimiglia 1940-1945: ricordi di guerra (con la collaborazione di Danilo Mariani e Franco Miseria), Comune, Studio fotografico Mariani, Dopolavoro ferroviario, Ventimiglia, 1995
I partigiani attaccano Villa Balzi per liberare un ferito di nome Autano

Ai primi di novembre [1943] i fuggitivi [Michael Ross e George Bell] giungono in Bagnasco […] Erano giunti in terra ligure senza nemmeno saperlo. Puntarono la mattina più a valle, in vista di un casolare. Ma un incontro del tutto fortuito cambierà i loro progetti, studiati per giorni e giorni. L’uomo incontrato era Renato Brunati e il luogo il paese di Baiardo […] i Porcheddu [n.d.r.: dalla loro abitazione, Villa Llo di Mare, sita in Arziglia di Bordighera (IM)] liberamente andarono incontro per salvare la vita dei due sconosciuti inglesi. Il ringraziamento, Ross, lo estende a Vincenzo Manuel Gismondi, a Federico Assandria e ad Elio Moraglia. “Beppe aveva ordinato di portarci in una casetta nel paesino di Negi ove vivevano sua moglie e i figli dopo l’arresto di Lina e Brunati” [Ross]. Dopo l’impresa fallita [n.d.r.: tentativo di andare in barca a motore da Bordighera per la Corsica, causa affondamento per avaria del natante prescelto!] i due fuggiaschi inglesi riuscirono a trovare riposo e calore umano ma dovettero lasciare le terre di Arziglia […]
Don Nino Allaria Olivieri in Ventimiglia … sentieri della speranza <ANPI, Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia, Nante Edizioni, Imperia>, 2006, ripubblicato in Quando fischiava il vento. Episodi di vita civile e partigiana nella Zona Intemelia, Alzani Editore <La Voce Intemelia – A.N.P.I. Sezione di Ventimiglia (IM)>, 2015

La zona davanti all’ex scalo merci ferroviario di Bordighera
I problemi erano tanti e tutti molto seri.. Abitavo a Bordighera tra lo scalo merci della stazione e una casa dove erano accasermati dei militi fascisti. Casa mia era vuota, perché i miei genitori erano sfollati, come era stato consigliato da Radio Londra, che suggeriva di abbandonare le case vicino ai nodi ferroviari perché soggetti a bombardamento. Dalle mie finestre controllavo agevolmente ogni movimento in stazione e nella casermetta dei fascisti.
Avevo notato che ogni notte i militi si recavano a scaricare le merci che arrivavano con il treno e lasciavano la caserma sguarnita.
Il gelataio Eccolo (Renzo Pirotelli) mi prestò il triciclo fatto a barchetta, con il quale durante l’estate vendeva i gelati sul lungomare di Bordighera e Vallecrosia. Mi procurai anche un attrezzo da scasso e un piccone, depositai tutto nel portone di casa mia e attesi la notte. Alle 2 regolarmente arrivò il convoglio e tutti i militi uscirono per andare a scaricare il treno. Mi precipitai a portare il triciclo con gli arnesi da scasso vicino all’ingresso della casermetta.
Piano piano, per fare meno rumore possibile, forzai la porta… Tre alla volta li caricai nel ventre della barchetta ed alla fine caricai le scatole di munizioni. Il triciclo era quasi colmo. Riportai il carretto nel portone di casa mia e camuffai il carico coprendolo con alcuni pezzi di legna da ardere e una coperta.
Prima che i militi tornassero, ero già sulla via Romana verso Vallecrosia… Angelo Athos Mariani in Giuseppe Mac Fiorucci, Gruppo Sbarchi Vallecrosia, ed. Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia < Comune di Vallecrosia (IM) – Provincia di Imperia – Associazione Culturale “Il Ponte” di Vallecrosia (IM)>, 2007

Bordighera (IM): Villa I Balzi
Il 3 di settembre 1944 poderosa azione in Bordighera: alcuni garibaldini del 6° distaccamento, compreso Martino Blancardi (Martinetto), attaccano di sorpresa il nemico a Selvadolce e catturano venti fascisti e ingenti quantitativi di armi comprendenti quattro mortai da 81 mm., centosessanta fucili, dieci mitra, dieci fucili mitragliatori con rispettive munizioni, quindi liberano parecchi prigionieri politici rinchiusi nelle carceri locali; il giorno dopo gli stessi attaccano Villa Balzi per liberare un ferito di nome Autano e disarmano un fascista alla Madonna della Ruota (testimonianza scritta di Martino Blancardi).
Francesco Biga, Storia della Resistenza Imperiese (I^ Zona Liguria), Vol. III. Da settembre a fine anno 1944, ed. Amministrazione Provinciale di Imperia, 1977

Alcuni partigiani di Bordighera furono attivi a partire dalla fine del 1944 nel Gruppo Sbarchi di Vallecrosia (IM), una struttura, al pari della Missione Corsaro di Ventimiglia (IM), di collegamento operativo con gli alleati, entrambe sotto il comando di Stefano Leo Carabalona, già eroico comandante dell’8° Distaccamento della IX^ Brigata d’Assalto Garibaldi “Felice Cascione”, prima, di Distaccamento della V^ Brigata “Luigi Nuvoloni” della II^ Divisione “Felice Cascione”, poi, distintosi in modo particolare rispettivamente nelle battaglie partigiane per Rocchetta Nervina (IM) e per Pigna (IM). E quando Carabalona venne l’8 febbraio 1945 gravemente ferito in un agguato in Vallecrosia (e curato in via provvisoria e fortunosamente dal prof. Gabetti nell’ospedale di Bordighera prima di essere messo in salvo a Nizza) a subentrargli nell’incarico fu proprio un patriota di Bordighera, Renzo Stienca Rossi. Adriano Maini

La mia storia nella Resistenza è legata a filo doppio con Renzo [“Stienca“] Rossi.
Nell’agosto del 1944 mi aggregai al gruppo partigiano di Girò [o Gireu, Pietro Gerolamo Marcenaro di Vallecrosia (IM)], che operava nella zona di Negi [Frazione di Perinaldo]. Dove godevamo anche dell’appoggio di Umberto [Gigetto] Sequi a Vallebona e di Giuseppe Bisso a Seborga; tutti e due membri del C.L.N. di Bordighera. Negi era il punto di contatto tra le varie formazioni partigiane che operavano nella zona, tra queste, quelle sotto il comando di Cekoff [o Cecof, Mario Alborno di Bordighera] e di Gino [Luigi Napolitano]… I tedeschi rastrellarono tutta la zona cercando “Leo”; “visitarono” anche la mia casa: sulla porta rimasero le impronte dei chiodi degli scarponi di quando sfondarono l’ingresso a calci. Ma non cercarono in cantina, si limitarono ad arraffare del cibo dalla cucina. Con Renzo Rossi nascondemmo tutti i documenti del S.I.M. e del C.N.L. [di Bordighera (IM)] nel mio giardino, preparandoci al trasferimento di “Leo” in Francia. Il Gruppo Sbarchi Vallecrosia aveva frattanto predisposto una barca. Renzo Rossi con Lotti avevano preavvisato i bersaglieri della necessità di effettuare l’imbarco quanto prima possibile. La collaborazione dei bersaglieri fu determinante per tutte le operazioni del Gruppo Sbarchi. Il sergente Bertelli comandava un gruppo di bersaglieri a Collasgarba – sopra Nervia di Ventimiglia – e aveva manifestato la volontà di aderire alla Resistenza. Fu avvicinato dai fratelli Biancheri, detti Lilò, per stabilire le modalità della diserzione, quando il plotone fu distaccato alla difesa costiera giusto sulla costa di Vallecrosia in prossimità del bunker alla foce del Verbone. I Lilò convinsero allora i bersaglieri a non disertare, ma ad operare dall’interno per consentire ed agevolare le nostre operazioni. Renzo Gianni Biancheri, “Rensu u Longu” in Giuseppe Mac Fiorucci, Op. cit.
6 novembre 1944
Oggi la nave ha sparato continuamente verso Bordighera e Ventimiglia dalle 6 di questa mattina fino alle 16,30.
[n.d.r.: dal diario di una ragazza rimasta ignota, figlia di albergatori di Sanremo]
Renato Tavanti, Sanremo. “Nido di vipere”. Piccola cronaca di guerra. Volume terzo, Atene Edizioni, 2006

All’ospedale [di Bordighera] “Leo” venne curato da due medici che conoscevo bene, il dr. Giribaldi e il dr. Gabetti, e assistito dalla caposala, infermiera Eva Pasini. Il dr. Gabetti mi disse che difficilmente “Leo” sarebbe sopravvissuto e che quindi conveniva ricoverarlo come “ferito da colpo d’arma da fuoco” e non rischiare la vita quando la polizia fascista avesse preso conoscenza del referto.

26 marzo 1945 – Dal CLN di Bordighera, Sezione SIM, al comando della I^ Zona Operativa Liguria – Segnalava che forse un certo “Viriga”, incaricato di compiere un’azione delicata a Vallecrosia, si fosse “lasciato scappare informazioni vitali” e, siccome risultava rifugiato nel frantoio di Massabò [Perinaldo (IM)], chiedeva al comando di svolgere indagini. Aggiungeva che “Renzo” [Renzo Stienca Rossi] si era nuovamente recato in Francia e se ne attendeva il ritorno.
Vincenzo [Manuel Gismondi], Elio [Moraglia] e Federico [Assandria], che avevano tentato di remare fino alla Corsica con Ross e Bell, sopravvissero tutti alla guerra, ma su una collina che domina il porto di Bordighera c’è ora un monumento dedicato ai partigiani che furono giustiziati o uccisi in azione. In cima alla lista c’è Renato Brunati. Beppe e tutta la famiglia Porcheddu furono incredibilmente fortunati e sopravvissero alla guerra. Ross si unì di nuovo al suo reggimento e poco tempo dopo in Europa la guerra finì. Tornò a Bordighera nel 1946 per un gioioso ricongiungimento con la famiglia Porcheddu ed in particolare con Giovanna che avrebbe sposato l’11 ottobre 1946. Anche sua sorella gemella, Amalia, avrebbe sposato un ufficiale britannico, il capitano Philippe Garigue (1917-2008) in una doppia cerimonia a ‘Villa Llo di Mare’.
Nel suo libro “The British Partisan”, Ross riconosce il contributo molto significativo e coraggioso di Beppe a sostegno degli Alleati e della resistenza contro il fascismo. Purtroppo non ho mai conosciuto il mio straordinario nonno, Beppe Porcheddu. Nel dicembre 1947, mentre organizzava una mostra della sua arte a Roma, scomparve per non essere mai più rivisto. Bordighera divenne una seconda casa per i miei genitori dove trascorsero insieme tanti anni felici. Mio padre è morto nel 2012 e mia madre nel 2019. La loro è stata una straordinaria storia d’amore.
David Ross, Ross, Michael (IT), Monte San Martino Trust

La collina di Montenero nella parte sovrastante Località Arziglia di Bordighera
2 aprile 1945 – Dal comando della V^ Brigata, Sez. SIM , prot. n° 370, al Comando della I^ Zona Operativa Liguria ed al comando della II^ Divisione – Venivano comunicate notizie riferite da un non meglio specificato interprete di Bordighera. “… Truppe tedesche e fasciste in allarme di 2° grado. Circa 1000 tedeschi hanno lasciato il fronte di Ventimiglia, dove tuttavia permane una divisione. Tutti i comandi tedeschi sono in procinto di essere trasferiti a Vallebona e a Borghetto [San Nicolò, Frazione di Bordighera]… A Bordighera si trovano solo dei bersaglieri. A Sasso [Frazione di Bordighera] vi sono 30 tedeschi con 2 pezzi d’artiglieria da 105 mm. Dalla punta di Sant’Ampelio di Bordighera a Ventimiglia c’è un bunker ogni 800 metri, ognuno dei quali presidiato da 11 fascisti, di cui un sergente, ed un tedesco. A Montenero [altura situata ampiamente nel territorio di Bordighera] si trovano 50 soldati tedeschi distribuiti in diverse postazioni, di cui alcune risultano finte“. 10 aprile 1945 – Dalla V^ Brigata “Luigi Nuvoloni”, Sez. SIM (Servizio Informazioni Militari), prot. n° 381, al Comando della I^ Zona Operativa Liguria ed al comando della II^ Divisione – Veniva comunicato quanto riferito dall’informatore tedesco La: che nella zona di Bordighera i tedeschi avevano ricevuto l’ordine di tenersi pronti per una prossima partenza per Verona e di comportarsi gentilmente verso la popolazione, e che venivano minate strade e colline… da documenti IsrecIm in Rocco Fava, Op. cit. Tomo II
Due fanti prigionieri fuggirono dal loro vagone

Tra gli uomini che dovettero subire i drammi della storia dopo l’8 settembre 1943 molti furono coloro che provenivano dall’estremo ponente ligure. E tra questi alcune storie personali degne di essere ricordate.

BIANCHERI GIOVANNI (20/1/1918) di Airole. G. a. F. 1^ Settore di Copertura. Catturato il 13 settembre 1943 a Fusine (UD) venne internato in Germania. Rientrato in Italia nel luglio 1945 fu ricoverato in Ospedale a Verona. Morì a Airole il 3 settembre 1945 per una malattia contratta in prigionia.
Il suo compaesano VIALE ANDREA (4/11/1919), aviere della Regia Aeronautica, catturato a Rodi (GRE) il 9 settembre 1943, non ebbe la possibilità di tornare a case e morì il 12 agosto 1944 in prigionia in Germania.


Non tornò più ad Apricale PISANO ENRICO (24/8/1923) marò presso il Comando Marina Egeo disperso a Rodi 11 settembre 1943. Di Bordighera erano BERSIA TERESIO (29/11/21), CALDO VITTORIO LUIGI (23/6/1922), il sottotenente SOLERI GIOVANNI 8/9/12 che morirono nei lager tedeschi, mentre ELLENA MATTEO, (Bordighera 25/1/1915) legionario della XXXIII Btg. Camicie Nere (alcuni legionari dei battaglioni camicie nere subirono la stessa sorte degli altri militari perché rifiutarono anch’essi di combattere a fianco dei tedeschi) disperso a Cattaro (Montenegro) il 30 settembre 1943, LORENZI VITTORIO (Bordighera 15/2/1920) marinaio della Regia Marina disperso a Sebenico (Jug) il 9 settembre 1943.
PASTORE GIOVANNI (12/2/12) di Camporosso disperso il 23 settembre, l’alpino di Castel Vittorio ALBERTI LUIGI (9/1/1920), catturato il 9 settembre a Chiusa all’Isarco (BZ), deceduto il 19 marzo 1944 in Germania come ALLAVENA GIUSEPPE, Castel Vittorio 11/10/1916, aviere scelto Spec. Montatore. Zithain Stalag IV B (Germania), catturato ad Atene il 10 settembre 1943 e deceduto per malattia in Germania il 21 ottobre 1944.
E poi:
TORNATORE ALFREDO, nato a Dolceacqua 14 marzo 1917. del 341^ Rgt. fanteria. deceduto in prigionia il 1 settembre 1944, catturato a Creta nel settembre 1943.
FERRARI FEDERICO LINO (Isolabona 28 aprile 1923), catturato dopo il 9 settembre 1943 in Alto Adige deceduto per malattia a Mauthausen (Sottocampo di Ebensee) il 16 aprile 1944. Una tragica coincidenza dettata dal destino. Federico Ferrari morì a Ebensee il 16 aprile 1944, lo stesso giorno del decesso di Federico Ferrari, ad alcune migliaia di chilometri di distanza, nel suo paese natio, veniva arrestato e deportato, anche lui a Ebensee, il suo compaesano GAVINO ALFREDO (Isolabona 5 maggio 1920) che si spense meno di un anno dopo, A Mauthausen fu internato anche CANE LINDO morto a a Isolabona 1947 per una malattia contratta in prigionia.
PIANETA GILDO (Isolabona 28 novembre 1913) deceduto a Villafranca il 13 settembre 1943, caduto mentre tentava la fuga dal treno durante il trasporto verso la prigionia in Germania. Il fatto venne ricordato dal quotidiano L’Arena del 13 settembre 2013. «Alla stazione di Villafranca, su un binario morto, era fermo un treno bestiame carico di militari italiani che, oltrepassato il Brennero, erano destinati ai campi di prigionia in Germania. Approfittando del treno fermo ed eludendo la sorveglianza, due fanti prigionieri fuggirono dal loro vagone, percorrendo pochi metri lungo la linea e nascondendosi in un cespuglio sotto la massicciata della ferrovia. Uno era Gildo Pianeta, fante di Isolabona, era sposato e a casa l’attendeva il piccolo Adriano. L’altro era Alberto Pomponi, di Bracciano. Ce l’avevano quasi fatta. Sarebbe bastato che tutto calasse nella quiete e al momento opportuno sarebbero schizzati fuori dal cespuglio, perdendosi nelle campagne dei dintorni. Ma non andò così. Da un altro vagone uscì un militare, anch’egli tentò la fuga e riuscì a eclissarsi in un campo di mais. I tedeschi lo avevano però visto. Si lanciarono al suo inseguimento invano. Fu così che, tornando al treno, notarono nascosti nel cespuglio Pomponi e Pianeta, che non ebbero scampo, uccisi da una raffica.».
LIMON CELESTINO di Olivetta San Michele (29/4/1909) del 43^ Rgt. fanteria, catturato da forze tedesche nel settembre 1943 in Albania, detenuto nel Lager di Bor, al sopraggiungere dell’Armata rossa, nell’inverno ’44, venne trasferito nel campo sovietico di Reni dove morì l’1 febbraio 1945, Il Campo di Reni n° 38 si trovava in Ucraina sul mar Nero ai confini con la Romania. Qui furono rinchiusi i militari italiani trovati dai sovietici nel campo di prigionia tedesco di Bor in Serbia. In questo campo sono accertati almeno 673 decessi di detenuti italiani.

COTTA ATTILIO, nato a Olivetta San Michele 24 settembre 1909. Carabiniere Reale 25^ Btg. Catturato a Cettigne (Montenegro) il 2 ottobre 1943. Internato Stalag IX B. Rientrato il 7 luglio 1945.
CASSINI GIUSEPPE, nato a Perinaldo 16 settembre 1916. Serg.te 23^ Sezione Sanità. Stalag tedesco 2 giugno 1944, catturato dopo l’8 settembre 1943.

SICARDI Giovanni, nato a Pigna 2 giugno 1917. Fante 341^ Rgt. fanteria. Baia di Suda, 8 febbraio 1944, disperso in mare nall’affondamento del piroscafo Petrella “adibito per il trasporto di prigionieri italiani dall’Egeo verso la Germania, fu affondato nelle acque di Creta, colpito da siluri del sommergibile HMS Sportsman. Dei 3.173 soldati italiani imbarcati, fatti prigionieri nelle isole dell’Egeo dopo l’8 settembre 1943, solamente 424 si salvarono”.
BOERO RODOLFO, nato a Rocchetta Nervina 21 maggio 1909. Rep. sconosciuto. Jugoslavia 21 settembre 1943
CROESI ENNIO, nato a San Biagio della Cima 14 ottobre 1922. Geniere. Stalag di Altengrabow (Germania) 29 aprile 1944, deceduto in prigionia, catturato dopo l’8 settembre 1943 in località sconosciuta.
MOLINARI ANTONIO, nato a San Biagio della Cima 14 gennaio 1923. + 8 settembre 1943 disperso in località sconosciuta.
MACCARIO ELIO, nato a Soldano 14 maggio 1923. Brigadiere Carabinieri. Germania 31 gennaio 1945, deceduto in prigionia, catturato dopo l’8 settembre 1943 in località sconosciuta.
ANFOSSO GIUSEPPE (Ninò), nato a Soldano 25 settembre 1923. Reparto sconosciuto. Grecia 17 gennaio 1944.
ANFOSSO SILVANO di Giuseppe e Anfosso Silvia, nato a Ventimiglia 26 maggio 1918. Tenente Rgt. Genio artieri. Grecia 18 ottobre 1943.
GIRALDI ALBERTO, nato a Ventimiglia 3 marzo 1923 divisione Acqui, disperso in mare in prossimità di Patrasso il 13 ottobre 1943, per il naufragio della motonave Marguerite impegnata nell’evacuazione di prigionieri italiani da Cefalonia.

GUGLIELMI LORENZO ALDO di Giovanni Battista e Guglielmi Lorenzina, nato a Vallebona 26 marzo 1918. Aviere. Catturato a Pola il 9 settembre 1943, internato in Germania. Rimpatriato dalla prigionia il 5 aprile 1945. Deceduto a Vallebona il 16 aprile 1945 per malatia contrata in prigionia.
LEONE FRANCESCO, nato a Vallecrosia 4 ottobre 1919. Artiglieria. Grecia 20 settembre 1943
ALBERTINI BRUNO, nato a Ventimiglia 20 settembre 1924. G. a F. 27^ Settore. Catturato a Fiume il 19 settembre 1943. Ospedale da Campo di Magdeburgo (Germania) 8 gennaio 1944, deceduto per malattia. Precedentemente internato nei Stalag X B e XI B.
BORRI FEDERICO, nato a Ventimiglia 8 luglio 1922. Cannoniere Marina Mil.. Rodi 11 settembre 1943, disperso.
COLTELLI GIOVANNI di Giulio e Lanteri Petronilla, nato a Ventimiglia 3 aprile 1923. 8^ Rgt. Bersaglieri. Germania 15 maggio 1944, deceduto in prigionia.
LORENZI GIOBATTA, nato a Ventimiglia 1 ottobre 1923. Cannoniere Marina Mil.. Rodi 11 settembre 1943, disperso.
Questa è una lista, che, come tutte le liste, può risulta asettica e non permette di valutare appieno la tragedia di tutti questi ragazzi che morirono resistendo consapevolmente o meno alla violenza imposta da una ideologia deteriore, moltissimi altri, i cosidetti IMI, riuscirono a tornare alle proprie case dopo mesi e mesi di fame, sofferenze, fatiche dalla schiavitù imposta loro dal nazismo.
Tra i tanti volti sconosciuti vorrei ricordare in modo particolare quattro figure, quattro ufficiali che attraverso il loro sacrificio, in modo diverso e con conclusioni diverse, diedero lustro al territorio che li vide nascere.
Il primo è il capitano di Vallecrosia ANTONIO VALGOI (19 agosto 1907) del 3° raggruppamento artiglieria di C.A. (Corpo d’Armata) caduto a Cefalonia il 22 settembre 1943, fucilato come quasi tutti gli ufficiali e sottuficiali della Divisione Acqui e MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE alla memoria. Questa è la motivazione della decorazione: «Comandante di reparto munizioni e viveri di un gruppo d’artiglieria, nei giorni immediatamente successivi all’armistizio partecipava attivamente e valorosamente ad aspra lotta. Al profilarsi dell’insuccesso delle nostre armi, informato dai suoi artiglieri che gli Ufficiali venivano passati per le armi e sollecitato a rifugiarsi all’ospedale militare, dove avrebbe potuto facilmente confondersi col personale sanitario perché laureato in medicina e chirurgia, rifiutava con orgogliosa fierezza il suggerimento per rimanere, fino all’ultimo, accanto ai soldati che la Patria gli aveva affidato. Subito dopo la cattura accortosi che il Comandante dell’unità avversaria faceva schierare armi automatiche intorno al Reparto, con l’intento di sterminare indiscriminatamente i suoi dipendenti, si portava decisamente avanti a tutti e dichiarava: “Sono io il Comandante di questi uomini. Sparate su di me”. Aveva appena finito di pronunciare queste parole che una raffica lo abbatteva esanime al suolo unitamente ai suoi valorosi artiglieri – Argostoli-Cefalonia (Grecia) 22 settembre 1943 MOVM.»
CASELLA ALDO, nato a Ventimiglia 12 marzo 1915, tenente dell’84° Rgt fanteria, che dopo l’8 settembre continuò a combattere ma contro i tedeschi nella Divisione Garibaldi sorta raccogliendo i superstiti delle divisioni del R.E.I. Veneza, Taurinense ed Emilia di stanza in Montenegro e Serbia. Combattè a fianco delle brigate partigiane jugoslave, contro i tedeschi. Tra l’8 settembre ’43 e la conclusione del conflitto si contano più di 20.000 caduti tra le file italiane. Al suo comando il generale CARLO RAVNIC che si spense a Bordighera il 2 marzo 1996. Casella cadde in combattimento il 18 ottobre 1944 a Brodarevo in Montenegro. Gli venne conferita una Medaglia di Bronzo al Valor Militare con la seguente motivazione: «Comandante di compagnia, già distintosi in precedenti azioni di guerra, si prodigava costantemente per il sempre maggiore rendimento bellico del reparto. Durante un furioso attacco di preponderanti forze nemiche guidava più volte all’assalto i propri uomini, sempre primo ove era maggiore il pericolo, più necessaria la presenza del comandante. Nella conseguente azione di sganciamento metteva in luce tutta la sua perizia. Il suo alto amor patrio, il suo sentito attaccamento al dovere. – Brodarevo, 16 novembre 1943. MBVM.»
il maggiore dei Carabinieri LIVIO DUCE, nato a Ventimiglia il 5 dicembre 1897. Studente al terzo anno di ingegneria all’Università di Genova, si arruolò volontario per partecipare alla Grande Guerra.
Al momento della mobilitazione nel 1940 fu trasferito all’XI Btg. mobilitato dell’Arma, al cui comando venne inviato in Dalmazia. Nel 1942 promosso maggiore, assumeva il comando del III C. A. dei Carabinieri impiegato per il controllo dell’Attica. Catturato nel settembre 1943 dai tedeschi, venne fucilato il 24 settembre 1943. «Comandante di battaglione carabinieri in territorio di occupazione, caduto in una imboscata con una piccola colonna e circondato da sovverchianti forza nemiche opponeva, benché ferito, accanita ed eroica resistenza imponendosi all’ammirazione degli stessi avversari, finché ferito un aseconda volta, sopraffatti e caduti quasi tutti i componenti della colonna, veniva catturato. Sottoposto ad indicibili sevizie materiali e morali, rifiutava sdegnosamente l’offerta di aver salva la vita a patto di sottoscrivere falsa dichiarazione atta a trarre in inganno altri reparti italiani. Appreso che un compagno di prigionia era stato fucilato dichiarava che, se gli fosse toccata la stessa sorte, avrebbe saputo morire da «italiano e da Carabiniere». Condotto al luogo del suplizio manteneva col suo contegno fede alla promessa, finché cadeva fulminato dal piombo del nemico che ne aveva soppresso il corpo ma non piegato lo spirito. Ammirevole esempio di virile coraggio e di elette virtù militari. – Montagne dell’Attica (Grecia), agosto 1943 – gennaio 1944. MOVM alla memoria.»
ADOLFO RIVOIR, nato a Vallecrosia nel 1895, figlio di genitori di fede valdese. Combattente nella prima guerra mondiale come sottufficiale di complemento, venne ferito gravemente, prima sul Monte Fior, poi sull’Ortigara. All’entrata in guerra dell’Italia nel 1940 Adolfo Rivoir è già un uomo maturo, sposato e con due figli piccoli. Combatte sul fronte greco-albanese; il 15 dicembre 1940 viene ferito gravemente sul Var i Lamit e nel luglio 1941 riceve la medaglia d’oro. Quando riprende in pieno le forze viene assegnato al Comando del 5° Reggimento alpini, quale comandante della caserma di Fortezza, presso Merano. L’8 settembre viene catturato dai tedeschi e inizia per lui l’internamento. Prima a Tschenstochau in Polonia, sede dello Oflag 367, poi a Norimberga, Oflag D, fino al 19 febbraio quando arriva a Altengrabow, Oflag A. Il 4 maggio del ’45 viene liberato dei sovietici e l’8 maggio comincia l’odissea che si conclude con il ritorno a Torre Pellice il 5 settembre 1945. Per tutta la durata della prigionia Adolfo Rivoir celò su di se la bandiera del V Alpini, che al momento dell’arresto riuscì a portare con sé, conservandola e nascondendola, sfuggendo sempre ai controlli dei tedeschi, fino a portarla in salvo in Italia. La sua odissea di prigioniero nei campi tedeschi è raccontata nel libro di Ivetta Fuhrmann, L’ufficiale che salvò la bandiera – Diario di prigionia in Polonia e in Germania, Claudiana, 2013.
Per ultima, un’esperienza diversa. Un ventimigliese che dopo l’8 settembre non fu costretto a salire sui monti, oppure entrare in clandestinità. Non conobbe neanche le sofferenze della prigionia ma partecipò alla Resistenza contro il nazifascismo combattendo nel CORPO ITALIANO DI LIBERAZIONE.
CROVESI IVO, nato a Saorge nel 1920 e residente a Ventimiglia. Frequenta il corso AUC e al termine viene nominato sottotenente e destinato al 5º alpini, battaglione Morbegno; dovrebbe partire per la Russia ma una domanda, presentata tempo addietro, per un corso paracadutisti, lo fa partire per Tarquinia dove, alla fine del periodo di addestramento, viene destinato alla divisione Nembo di rincalzo alla Folgore, impegnata nei deserti della Libia. Il suo reparto, in attesa d’impiego, è accantonato in Sardegna. Arriva l’8 settembre e una mattina la sua caserma è circondata dai Tedeschi che, con una sydecar e pochi camion di soldati, chiedono al comandante di arrendersi. Questi risponde che se loro sono accerchiati, i suoi soldati hanno cinquemila paracadutisti attorno, pronti ad aprire il fuoco. Si arriva ad un gentleman agreement e il reparto germanico viene scortato fino alle Bocche di Bonifacio e lasciato andare in Corsica. La divisione Nembo, nel frattempo rinforzata dei resti delle battaglie in Libia, viene trasferita a Napoli. Gli Americani li vogliono al loro fianco, gli Inglesi li considerano prigionieri di guerra e così per due volte salgono e scendono dalle navi, senza sapere se destinati al fronte o a un campo di concentramento. A Ortona, la sua divisione partecipa per la prima volta ad operazioni di guerra e, benché male armati e con soli due cannoni, escono spesso in avanguardia in micidiali campi minati e sostengono aspri combattimenti sull’Appennino a Filtrano, Castellone di Suada e Grinzano, nel Bolognese. Negli ultimi giorni di guerra, a Casalecchio dei Conti, nel Bolognese, nel corso di cruenti combattimenti con le truppe tedesche, viene decorato con una medaglia di Bronzo. Nel dopoguerra si trasferisce in Venezuela dove, per anni, presiede la locale Associazione Nazionale Alpini. Ritornava spesso a Ventimiglia e mantenne sempre vivi i contatti con gli amici ventimigliesi.
«Motivazione Medaglia d’Argento al Valor Militare
Crovesi Ivo, Sottotenente Rgt. Paracad. “Nembo”, II Btg.
– Comandante di un plotone fucilieri di provato valore, durante una giornata di aspri combattimenti, organizzava il fuuoco delle sue armi in modo da infligere al nemico notevoli perdite e dare valido appoggio ad altri plotoni della sua compagnia. Assicurava il rifornimento munizioni del reparto fortemente impegnato, trascinando con l’esempio i suoi uomini, attraverso un terreno aspro, intensamente battuto dal fuoco nemico. Nobile esempio di attaccamento al dovere. – Casalecchio dei Conti, 19 aprile 1945. MBVM».
Giorgio Caudano, Gli eroi sono tutti giovani e belli. I Caduti della Lotta di Liberazione nella I^ Zona Operativa Liguria, ed. in pr., 2020
[ n.d.r.: altri lavori di Giorgio Caudano: Marco Cassini e Giorgio Caudano, Bordighera al tempo di Bicknell e Monet, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, 2021; Giorgio Caudano, L’immagine ritrovata. Ventimiglia e dintorni nei dipinti dell’Ottocento e primo Novecento, Alzani Editore, 2021; La libera Repubblica di Pigna. Parentesi di democrazia (29 agosto 1944 – 8 ottobre 1944), (a cura di) Paolo Veziano con il contributo di Giorgio Caudano e di Graziano Mamone), Comune di Pigna, IsrecIm, Fusta Editore, 2020; Giorgio Caudano, Dal Mare alla Trincea… memorie di uomini, BB Europa, Cuneo, 2019; Silvia Alborno, Gisella Merello, Marco Farotto, Marco Cassini, Giorgio Caudano, Franck Vigliani, curatori della mostra Claude Monet, ritorno in Riviera, catalogo a cura di Aldo Herlaut, Silvana Editoriale, Milano 2019; La Magnifica Invenzione. I pionieri della fotografia in Val Nervia 1865-1925, a cura di Marco Cassini e Giorgio Caudano, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, 2016; Giorgio Caudano, Pigna. Storia di un paese, ed. in pr., 2016 ]
Ebrei deportati, arrestati a Bordighera

Raimonda Devaux, figlia di Luciano Devaux e Elisa Carrier è nata in Francia a Chauny il 31 luglio 1901. Coniugata con Orlando Perera. Arrestata a Bordighera (Imperia). Deportata nel campo di concentramento di Bergen Belsen. È sopravvissuta alla Shoah.
luogo di arresto: Bordighera
data di arresto: 15/02/1944
luogo di detenzione: IMPERIA carcere
luogo di raccolta: FOSSOLI campo
numero di convoglio: convoglio n. 17, FOSSOLI campo 02/08/1944
data di partenza del convoglio: 02/08/1944
data di arrivo del convoglio: 05/08/1944
campo di destinazione: Bergen Belsen
Elide Levi è nata in Italia a Modena il 7 agosto 1875. Coniugata con Giuseppe Benedetto Bassani. Arrestata a Bordighera (Imperia). Deportata nel campo di sterminio di Auschwitz. Non è sopravvissuta alla Shoah.
luogo di arresto: Bordighera
data di arresto: 24/10/1943
luogo di detenzione: MILANO carcere
luogo di raccolta: MILANO carcere
destino: Morto/a in campo di sterminio
numero di convoglio: convoglio n. 06, MILANO carcere 30/01/1944
data di partenza del convoglio: 30/01/1944
data di arrivo del convoglio: 06/02/1944
campo di destinazione: Auschwitz
numero di matricola: S
Giuseppe Benedetto Bassani, figlio di Isacco Bassani e Delfina Colorni è nato in Italia a Modena l’ 11 novembre 1866. Coniugato con Elide Levi. Arrestato a Bordighera (Imperia). Deportato nel campo di sterminio di Auschwitz. Non è sopravvissuto alla Shoah.
luogo di arresto: Bordighera
data di arresto: 24/10/1943
luogo di detenzione: MILANO carcere
luogo di raccolta: MILANO carcere
destino: Morto/a in campo di sterminio
numero di convoglio: convoglio n. 06, MILANO carcere 30/01/1944
data di partenza del convoglio: 30/01/1944
data di arrivo del convoglio: 06/02/1944
campo di destinazione: Auschwitz
numero di matricola: S
Linda Misrachi è nata in Turchia a Istanbul nel 1892. Arrestata a Bordighera (Imperia). Deportata nel campo di sterminio di Auschwitz. Non è sopravvissuta alla Shoah.
luogo di arresto: Bordighera
data di arresto: 26/11/1943
luogo di detenzione: IMPERIA carcere
luogo di raccolta: MILANO carcere
destino: Morto/a in campo di sterminio
numero di convoglio: convoglio n. 5, MILANO carcere 06/12/1943
data di partenza del convoglio: 06/12/1943
data di arrivo del convoglio: 11/12/1943
campo di destinazione: Auschwitz
numero di matricola: –
Virginia Misrachi è nata in Turchia a Istanbul nel 1872. Arrestata a Bordighera (Imperia). Deportata nel campo di sterminio di Auschwitz. Non è sopravvissuta alla Shoah.
luogo di arresto: Bordighera
data di arresto: 26/11/1943
luogo di detenzione: IMPERIA carcere
luogo di raccolta: MILANO carcere
destino: Morto/a in campo di sterminio
numero di convoglio: convoglio n. 5, MILANO carcere 06/12/1943
data di partenza del convoglio: 06/12/1943
data di arrivo del convoglio: 11/12/1943
campo di destinazione: Auschwitz
numero di matricola: S
Isaac Assa, figlio di Salvatore Assa e Mercada Behar è nato in Turchia a Istanbul il 12 dicembre 1882. Coniugato con Camelia Abolaffio. Arrestato a Bordighera (Imperia). Deportato nel campo di sterminio di Auschwitz. Non è sopravvissuto alla Shoah.
luogo di arresto: Bordighera
data di arresto: 18/11/1943
luogo di detenzione: GENOVA carcere
luogo di raccolta: MILANO carcere
destino: Morto/a in campo di sterminio
numero di convoglio: convoglio n. 05, MILANO carcere 06/12/1943
data di partenza del convoglio: 06/12/1943
data di arrivo del convoglio: 11/12/1943
campo di destinazione: Auschwitz
numero di matricola: S
Gabriella Perera, figlia di Orlando Perera e Raimonda Devaux è nata in Italia a Genova il 26 aprile 1932. Arrestata a Bordighera (Imperia). Deportata nel campo di concentramento di Ravensbrueck. È sopravvissuta alla Shoah.
luogo di arresto: Bordighera
data di arresto: 15/02/1944
luogo di detenzione: VALLECROSIA campo
luogo di raccolta: FOSSOLI campo
numero di convoglio: convoglio n. 16, FOSSOLI campo 02/08/1944
data di partenza del convoglio: 02/08/1944
data di arrivo del convoglio: 05/08/1944
campo di destinazione: Ravensbrueck
numero di matricola: 49542
Mirella Perera, figlia di Orlando Perera e Raimonda Devaux è nata in Italia a Milano il 4 dicembre 1924. Arrestata a Bordighera (Imperia). Deportata nel campo di concentramento di Ravensbrueck. È sopravvissuta alla Shoah.
luogo di arresto: Bordighera
data di arresto: 15/02/1944
luogo di detenzione: VALLECROSIA campo
luogo di raccolta: FOSSOLI campo
numero di convoglio: convoglio n. 16, FOSSOLI campo 02/08/1944
data di partenza del convoglio: 02/08/1944
data di arrivo del convoglio: 05/08/1944
campo di destinazione: Ravensbrueck
numero di matricola: ?
data di liberazione: 15/04/1945
Clotilde Segre, figlia di Emanuele Segre e Vittorina Levi è nata in Italia a Torino il 9 maggio 1875. Arrestata a Bordighera (Imperia). Deportata nel campo di sterminio di Auschwitz. Non è sopravvissuta alla Shoah.
luogo di arresto: Bordighera
data di arresto: 26/11/1943
luogo di detenzione: IMPERIA carcere
luogo di raccolta: MILANO carcere
destino: Morto/a in campo di sterminio
numero di convoglio: convoglio n. 05, MILANO carcere 06/12/1943
data di partenza del convoglio: 06/12/1943
data di arrivo del convoglio: 11/12/1943
campo di destinazione: Auschwitz
numero di matricola: S
Eva Raffaella Segre, figlia di Emanuele Segre e Vittorina Levi è nata in Italia a Moncalieri il 10 settembre 1885. Coniugata con Salvatore Samuele Segre. Arrestata a Bordighera (Imperia). Deportata nel campo di sterminio di Auschwitz. Non è sopravvissuta alla Shoah.
luogo di arresto: Bordighera
data di arresto: 24/11/1943
luogo di detenzione: GENOVA carcere
luogo di raccolta: MILANO carcere
destino: Morto/a in campo di sterminio
numero di convoglio: convoglio n. 05, MILANO carcere 06/12/1943
data di partenza del convoglio: 06/12/1943
data di arrivo del convoglio: 11/12/1943
campo di destinazione: Auschwitz
numero di matricola: –
Salvatore Samuele Segre figlio di Bonaiuto Segre è nato in Italia a Saluzzo il 13 settembre 1880. Coniugato con Eva Raffaella Segre. Arrestato a Bordighera (Imperia). Deportato nel campo di sterminio di Auschwitz. Non è sopravvissuto alla Shoah.
luogo di arresto: Bordighera
data di arresto: 24/11/1943
luogo di detenzione: GENOVA carcere
luogo di raccolta: MILANO carcere
destino: Morto/a in campo di sterminio
numero di convoglio: convoglio n. 05, MILANO carcere 06/12/1943
data di partenza del convoglio: 06/12/1943
data di arrivo del convoglio: 11/12/1943
campo di destinazione: Auschwitz
numero di matricola: S
Eleonora Bensussan figlia di Bonomo Bensussan è nata in Grecia a Salonicco. Coniugata con Alberto Mosseri. Arrestata a Bordighera (Imperia). Deportata nel campo di sterminio di Auschwitz. Non è sopravvissuta alla Shoah.
luogo di arresto: Bordighera
data di arresto: 26/11/1943
luogo di detenzione: IMPERIA carcere
luogo di raccolta: MILANO carcere
destino: Morto/a in campo di sterminio
numero di convoglio: convoglio n. 5, MILANO carcere 06/12/1943
data di partenza del convoglio: 06/12/1943
data di arrivo del convoglio: 11/12/1943
campo di destinazione: Auschwitz
numero di matricola: –
Camelia Abolaffio figlia di Jacob Abolaffio è nata in Turchia a Smirne il 24 marzo 1902. Coniugata con Isaac Assa. Arrestata a Bordighera (Imperia). Deportata nel campo di sterminio di Auschwitz. Non è sopravvissuta alla Shoah.
luogo di arresto: Bordighera
data di arresto: 18/11/1943
luogo di detenzione: GENOVA carcere
luogo di raccolta: MILANO carcere
destino: Morto/a in campo di sterminio
numero di convoglio: convoglio n. 05, MILANO carcere 06/12/1943
data di partenza del convoglio: 06/12/1943
data di arrivo del convoglio: 11/12/1943
campo di destinazione: Auschwitz
numero di matricola: S
André Jacques Assa, figlio di Isaac Assa e Camelia Abolaffio è nato in Francia a Parigi l’ 11 maggio 1927. Arrestato a Bordighera (Imperia). Deportato nel campo di sterminio di Auschwitz. È sopravvissuto alla Shoah.
luogo di arresto: Bordighera
data di arresto: 18/11/1943
luogo di detenzione: GENOVA carcere
luogo di raccolta: MILANO carcere
numero di convoglio: convoglio n. 05, MILANO carcere 06/12/1943
data di partenza del convoglio: 06/12/1943
data di arrivo del convoglio: 11/12/1943
campo di destinazione: Auschwitz
numero di matricola: 167971
data di liberazione: 11/04/1945
[…] Fonti: Il libro della memoria : gli ebrei deportati dall’Italia, 1943-1945 / Liliana Picciotto ; ricerca della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea. – Ed. 2002: altri nomi ritrovati. – Milano : Mursia, 2002, pp. 77-80, pp. 66-71.
Digital Library
[…] Abbiamo qualche cifra legata all’attività di questo campo?
“Il campo di raccolta di Vallecrosia funzionò come tale, dal 9 febbraio al 2 agosto 1944, secondo quanto risulta da una relazione del Questore di Imperia del 10 agosto 1944 e da quella del Direttore del campo, del 28 giugno 1944, indirizzate entrambe al Ministero dell’Interno della Repubblica Sociale. In esso vennero detenuti, ciascuno per un periodo assai breve: circa 40 persone. A questo proposito, interessante è la vicenda che di due sorelle detenute, Gabriella e Mirella Perera e della loro madre, Raimonda Devaux, arrestate tutte insieme, in quanto ebree, a Bordighera, dove abitavano, il 15 febbraio del 1944 e subito portate al campo di Vallecrosia. Un altro figlio della signora Devaux fu arrestato, come ebreo, a Milano, l’11 settembre del 1944 e finì anch’egli in un Konzentration-lager in Germania. E’ da ricordare, in riferimento a questa vicenda, che il padre, Orlando Perera, non fu arrestato, poiché di religione cattolica; i suoi tre figli invece lo furono e vennero successivamente deportati in Germania, in quanto ritenuti automaticamente ebrei poiché nati da donna ebrea e, secondo la legge talmudica, tutti i nati da donna ebrea sono considerati ebrei”.
Quale epilogo ebbe la vicenda delle sorelle Perera?
“Gabriella, che all’epoca aveva 12 anni, venne poi trasferita da Vallecrosia al centro di raccolta di Fassoli da cui venne inviata al carcere di Verona e quindi al Konzentrationlager di Ravensbrueck. Fu liberata dagli americani, il 30 aprile del 1945e rientrò in Italia. Mirella, all’epoca ventenne, assieme alla madre finì al Konzentrationlager di Bergen-Belsen e venne liberata dagli americani, il 15 aprile del 1945, rientrando quindi in Italia. Durante la loro breve detenzione nel “campo” di Vallecrosia le sorelle Perera e la loro madre furono assistite da alcune compagne di scuola di Mirella: Angela Biancheri ed Esterina Ursida, che, rientrando a casa dalla Scuola Maria Ausiliatrice di Vallecrosia e passando accanto al campo, portarono loro viveri di conforto”.
Ci sono altre storie che possiamo ricordare?
“Altra vicenda interessante du quella di Franco Bragadin che, nel mese di febbraio del 1944, prese alloggio al primo piano della villetta di Giorgio Pellegrino nella via Romana, attuale civico 73, per poter essere vicino e assistere la moglie ebrea, arrestata a Imperia, il 12 febbraio del 1944 e detenuta nel campo di Vallecrosia, sino al 22 febbraio del 1944, quando venne inviata al campo di Fossoli, per poi essere trasferita in Germania. Pare che si sia salvata e che abbia poi preso dimora a Genova”.
Gustavo Ottolenghi intervistato da Fabrizio Tenerelli, Shoah, a Vallecrosia quel campo di concentramento terribile ma sconosciuto, Vivi Israele, 24 gennaio 2019
Non c’erano rose a Ravensbrück nell’estate del 1944, quando Gabriella Perera, dodici anni, arrivò al lager nascosto tra i boschi, 80 chilometri a nord di Berlino, insieme con la mamma Raimonda Devaux e la sorella ventenne Mirella, portate via a febbraio, dalla loro casa di Bordighera, dai repubblichini. Erano partite da Vallecrosia, estremo ponente ligure: un piccolo campo di raccolta della Rsi – praticamente dimenticato o più facilmente una memoria rimossa, com’è accaduto a decine e decine di altri in Italia – un edificio austero a neanche quindici chilometri dal confine francese che avrebbe significato la salvezza e la libertà, per lei come per le altre donne ebree recluse. Una ex caserma diventata prigione per gli ebrei e i detenuti politici ma anche per i militari che si erano rifiutati di aderire alla Repubblica sociale, insieme con le famiglie dei partigiani e dei giovani renitenti al bando di Badoglio. Gabriella, che riuscì a tornare, dopo aver trascorso un anno tra Ravensbrück e Bergen Belsen, e a vivere la sua vita a Genova, raccontava cinquant’anni dopo il suo disorientamento ma anche l’amarezza e la rassegnazione: nella sua famiglia, come in molte altre, si sapeva quale futuro fosse destinato agli ebrei; la speranza di sopravvivere, o anche solo di non vivere al peggio quei mesi, era affidata all’incontro con poche, singole persone, e ai loro comportamenti.
I tedeschi mi hanno tolto tutto e, inoltre, mi hanno umiliata con l’intenzione di disumanizzarmi; però nella cattiva sorte sono stata fortunata. Infatti, una kapò mi aveva offerto un po’ del suo spazio in un letto che era molto meglio del mio. L’orrore che ha affrontato, invece, Gabriella non lo racconta. Nella sua testimonianza, davanti ai ragazzi di una scuola media, dice di aver assistito a episodi tragici e di averli anche subiti «ma non posso descriverli perché siete troppo piccoli»
[…] No, non c’erano le rose, allora. Ci sono oggi, piantate lungo i muri della recinzione, sopra la terra che ricopre ciò che resta delle tante che da quel campo, nascosto tra i boschi, affacciato su un laghetto circondato da conifere e betulle […]
tratto da “DESTINAZIONE RAVENSBRÜCK. L’orrore e la bellezza nel lager delle donne” di DONATELLA ALFONSO, LAURA AMORETTI, RAFFAELLA RANISE
Redazione, Destinazione Ravensbruck. Le rose fioriranno ancora, ANPI Genova, 4 febbraio 2020
Alcune erano bambine, partite sole o con l’intera famiglia, altre ragazze di vent’anni, madri di famiglia oppure già anziane.
Sui treni che le portavano al campo di concentramento di Ravensbrück il lager delle donne, a nord di Berlino, finirono detenute politiche, prostitute, o appartenenti a famiglie ebraiche. Reiette da isolare, da eliminare, per il regime nazista. Mille tra le italiane deportate, di ogni età, non tornarono mai: tra loro anche alcune passate per un piccolo e quasi dimenticato centro di detenzione nell’estremo ponente ligure, a Vallecrosia, simbolo del desiderio di rimozione. La storia di queste donne, ragazze e bambine, i ricordi, la capacità che ebbero molte di loro, nonostante la tragedia che stavano vivendo, di ritrovare un affetto, un gesto, un sorriso, si affiancano ai momenti più cupi vissuti nel lager e, per le sopravvissute, riportati nella vita vissuta a partire dal loro ritorno […]
Donatella Alfonso, Laura Amoretti, Raffaella Ranise, Destinazione Ravensbrück. L’orrore e la bellezza nel lager delle donne, All Around, 2020
Campo di concentramento di Vallecrosia
Data:
28-02-1944
Ente intestario:
Repubblica sociale italiana. Commissariato PS di Ventimiglia. Campo di concentramento di Vallecrosia
Autore:
Marchetti
Qualifica:
Commissario di Polizia. Dirigente del campo
Destinatario:
Comando Guardia Nazionale Repubblicana Ventimiglia
Contenuto:
Ordine di trasferimento di due donne ebree dal campo di concentramento di Vallecrosia al campo di concentramento di Fossoli.
Luoghi citati:
Vallecrosia – Campo di concentramento RSI Fossoli – Campo di concentramento RSI
documento riprodotto in I campi fascisti
Nel caso di Ross e dei suoi compagni quei partigiani furono salutati come eroi

Le prime voci di antifascismo a Vallecrosia si ebbero nel 1940/41 da parte di Achille [Lamberti “Andrea“], di Francesco “Cé” Garini, di “Girò”(1), di Aldo Lotti e di altri. Un antifascismo molto riservato, anche perché le ritorsioni erano molto dure, come nel caso di Alipio Amalberti (2), zio materno di “Girò“, che per aver gridato in un bar di Vallecrosia “Viva la Francia” venne dapprima schedato e successivamente costantemente perseguitato, fino a essere fucilato per ritorsione dopo essere stato preso come ostaggio. Renato “Plancia” Dorgia in Giuseppe Mac Fiorucci, Gruppo Sbarchi Vallecrosia, ed. Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia – Comune di Vallecrosia (IM) – Provincia di Imperia – Associazione Culturale “Il Ponte” di Vallecrosia (IM), 2007
(1) Gireu/Giraud, Pietro Gerolamo Marcenaro, il quale risultava latitante già nel verbale della Questura (fascista) di Imperia del 15 giugno 1944, riferito alle indagini ed agli arresti effettuati verso la fine di maggio nella zona di Ventimiglia e di Bordighera a danno del costituendo CLN di Ventimiglia, del già esistente CLN di Bordighera, del gruppo antifascista “Giovane Italia” e di altri patrioti collegati, documento edito in don Nino Allaria Olivieri, Ventimiglia partigiana… in città, sui monti, nei lager 1943-1945, a cura del Comune di Ventimiglia, Tipolitografia Stalla, Albenga, 1999, pp. 9, 24
(2) Alipio Amalberti nato a Soldano (IM) l’11 febbraio 1901… Già nelle giornate che seguirono l’8 settembre metteva in piedi un’organizzazione per finanziare ed armare i gruppi che si stavano formando in montagna [a Baiardo, borgo in altura, alle spalle di Sanremo] insieme a Renato Brunati [di Bordighera, fucilato dalle SS il 19 maggio 1944 sul Turchino] e Lina Meiffret [proprietaria di una villa poco fuori Baiardo, punto di riferimento e talora rifugio di quella piccola banda, venne deportata pochi mesi dopo in un campo di concentramento in Germania, da cui tornò fortemente provata, ma salva]. Amalberti fu arrestato il 24 maggio 1944 a Vallecrosia e tenuto come ostaggio, in quanto segnalato più volte come sovversivo. Venne fucilato a Badalucco il 5 giugno 1944 come ritorsione ad un'azione del distaccamento di Artù <Arturo Secondo> compiuta il 31 maggio 1944. Giorgio Caudano [Giorgio Caudano, Dal Mare alla Trincea… memorie di uomini, BB Europa, Cuneo, 2019; Silvia Alborno, Gisella Merello, Marco Farotto, Marco Cassini, Giorgio Caudano, Franck Vigliani, curatori della mostra Claude Monet, ritorno in Riviera, catalogo a cura di Aldo Herlaut, Silvana Editoriale, Milano 2019; La Magnifica Invenzione. I pionieri della fotografia in Val Nervia 1865-1925, a cura di Marco Cassini e Giorgio Caudano, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, 2016]
La propaganda antifascista e antitedesca fu praticata nella zona di Bordighera da Renato Brunati [Renato Brunati, arrestato il 6 gennaio 1944, deportato a Genova e fucilato dalle SS il 19 maggio 1944 sul Turchino] e da me in un contempo indipendentemente, senza che nemmeno ci conoscessimo: ma nel 1940 ci incontrammo e d’impulso associammo i nostri ideali e le nostre azioni, legati come ci trovammo subito anche da interessi intellettuali ed artistici. La vera azione partigiana s’iniziò dopo il fatale 8 settembre 1943, allorchè Brunati e la sig. Maiffret [Lina Meiffret] subito dopo l’occupazione tedesca organizzarono un primo nucleo di fedeli […] Verso la metà di novembre due ufficiali inglesi, fuggiaschi del campo di ferma vennero a capitar nella zona di Bajardo, ricoverati e confortati dai nostri, sistemati poi nottetempo in un casolare di vetta. Fu poi progettata la fuga in Corsica: ma il 1° tentativo perì per la defezione del marinaio che s’era assunto l’apparecchiamento della barca: tuttavia i 2 inglesi scesero ad Arziglia in casa mia, guidati dai capi in pieno equipaggiamento partigiano a mezzogiorno per via Aurelia sotto il naso dei tedeschi: da Arziglia si trasferirono alla casa di Brunati, alla Madonna della Ruota ma una sorpresa della polizia che arrestava Brunati e la Maiffret costrinse nuovamente gli inglesi a raggiungere casa nostra ove restarono 15 giorni. I 2 capi vennero rilasciati per insufficienza di prove il 22 dicembre, raggiunsero Bajardo ove già erano tornati gli inglesi. Un nuovo tentativo di fuga in Corsica venne organizzato in casa mia coll’aiuto di patrioti bordigotti […] Un canotto di Donegani, trafugato venne adattato col fuoribordo acquistato con fondi di Giacometti equipaggiato e messo in acqua: vi salirono… i 2 inglesi ed i nominati patrioti, dopo un breve soggiorno in casa mia per gli ultimi preparativi. Ma l’imbarco avvenuto felicemente ad onta della attiva sorveglianza tedesca, non ebbe buon esito, chè la barca si empì d’acqua a 200 metri da riva ed a stento i fuggiaschi raggiunsero la costa rifugiandosi poi da me, fradici ed avendo salvato solo il moto. Da allora i 2 inglesi restarono in casa fino al 25 gennaio ’45, salvo un breve soggiorno a Bajardo nel gennaio ‘44. Gismondi fu arrestato […] Purtroppo il 14 febbraio 1944 Brunati e la Maiffret, venivano definitivamente presi dai repubblicani […] la presenza in casa mia dei 2 ufficiali inglesi pur consentendomi i collegamenti con ufficiali del S.I.M. e di partigiani, non mi permetteva d’assumere posizioni ufficiali: avevo promesso a Brunati ed alla Maiffret di portare in salvo ad ogni costo i 2 alleati […] Nel gennaio 1945 la Signora Marchesi, moglie del capo comunista Concetto Marchesi, e la figlia sposata Mendelssohn con un ebreo americano venivano ricoverate in casa mia coll’aiuto del dott. Marchesi, fratello di Concetto; esse sottostavano alla taglia di 1 milione, già applicata a Concetto Marchesi; fuggito questo in Svizzera le sue familiari rilevarono il funesto privilegio. Esse restarono in casa mia 25 giorni mentre ivi albergavano pure i 2 ufficiali inglesi; la prudenza e infinite cautele oltre al volere degli ospiti stranieri ci obbligarono ad occultare la presenza di questi alle signore Marchesi: e ci riuscimmo. Il 24 gennaio il dott. Marchesi precipitatosi in casa mia comunicò che i tedeschi dovevan partire entro 2 giorni, prelevando tutti i designati ostaggi di cui io risultai capolista. Si impose una fuga generale; Marchesi collocò altrove cognata e nipote, noi ci rifugiammo nella villa di Kurt Hermann… nazista, naturalmente a sua insaputa: i 2 ufficiali inglesi, guidati da mio figlio pei monti, di notte, raggiunsero rifugi ignoti, mentre mio figlio scendeva la costa in attesa degli avvenimenti. La notizia dataci risultò imprecisa, chè la fuga tedesca tardò ancora 3 mesi. Ma i 2 inglesi dopo romanzesche avventure in montagna e sulla costa di Vallecrosia raggiunsero la Francia e si misero finalmente al sicuro. Oggi scrivono dall’Inghilterra […] I 2 ufficiali inglesi si chiamano: Michael Ross e George Bell. Altro aiuto avemmo nell’occultamento dei 2 inglesi dal compagno Luigi Negro, autista della villa Hermann alla Madonna della Ruota. Egli ospitò una notte i 2 alleati nella detta villa, nonostante la permanenza di scolte tedesche nelle adiacenze e la possibilità di sorprese da parte del padrone e dei suoi accoliti. Giuseppe Porcheddu, manoscritto (documento IsrecIm) edito in Francesco Mocci (con il contributo di Dario Canavese di Ventimiglia), Il capitano Gino Punzi, alpino e partigiano, Alzani Editore, Pinerolo (TO), 2019
Aveva 49 anni Giuseppe Porcheddu, per tutti Beppe, quando scompare due giorni dopo il Natale del 1947. […] Antifascista – pur firmando nel 1935 le illustrazioni del Balilla regale di Arnaldo Cipolla – ospita nella villa di Bordighera durante la guerra moglie e figlia di Concetto Marchesi, il grande latinista, partigiano comunista. E poi due ufficiali britannici nascosti in una stanza vicino alla biblioteca, dove spesso un militare della Wehrmacht si presenta per chiedere a prestito uno dei tanti libri in tedesco che Porcheddu acquista per ispirarsi nei suoi disegni. Giovanna, figlia del disegnatore, sposerà a guerra finita uno dei due inglesi [Michael Ross]. L’altra, Amalia, convolerà lo stesso giorno con un altro ufficiale del Regno Unito di stanza in Liguria […] Leonardo Bizzaro, Porcheddu, la matita che sparì a Natale, la Repubblica, 20 ottobre 2007
Si sottolinea che il Decreto legislativo del Duce 14 giugno 1944-XXII, n. 393, prevedeva: “Art. 3. Chi concede ospitalità o presta comunque aiuto a prigionieri di guerra evasi dai campi di concentramento o dai luoghi di pena, ovvero ad appartenenti alle forze armate nemiche, allo scopo di facilitarne la fuga o di occultarne la presenza, è punito con la morte. Art. 4. Chi concede ospitalità alle persone indicate nell’articolo 2 o in qualsiasi altro modo le aiuta ad eludere le investigazioni delle autorità e sottrarsi alle ricerche di questa è punito con l’ergastolo. Art. 5. Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, avendo notizia della presenza di prigionieri di guerra o di internati civili evasi, ovvero di internati civili sottrattisi all’esecuzione dell’ordine di internamento o di appartenenti alle forze armate nemiche, non ne fa immediatamente denuncia alla più vicina autorità è punito con la reclusione fino a venti anni.”
Adriano Maini
Nell’imperiese la resistenza era organizzata da gente comune, come Renato Dorgia e Marcenaro [“Girò/Gireu/Giraud“] Pietro, che ho incontrato per farmi raccontare come hanno vissuto il periodo di guerra. Innanzitutto, ho chiesto loro il motivo che li aveva spinti a rifugiarsi in montagna a condurre una vita da partigiani contro l’occupazione nazifascista. Renato Dorgia, il cui soprannome in guerra era “Plancia“, era uno studente, chiamato a radunata dalla Repubblica di Salò […] si rifugiò in montagna dove venne contattato da un gruppo di partigiani di cui faceva parte anche mio nonno [Achille “Andrea” Lamberti] […] molti diventarono partigiani per le loro idee, come nel caso di Marcenaro Pietro, detto “Gerumin“, che come mio nonno era stato animato dalle nuove idee comuniste e che di propria volontà si era unito ai partigiani in montagna. […] disturbare il nemico tramite azioni diversive che vedevano “Girumin” e “Plancia” rubare armi al nemico per poi usarle contro. Al contrario di altri gruppi partigiani, quelli dell’Imperiese non ricevettero alcun aiuto dagli alleati, se non negli ultimi mesi di guerra. […] contattare più ragazzi che fosse possibile per convincerli ad unirsi ai partigiani […] Gli alleati diffidavano dei partigiani dell’estremo ponente ligure, da loro considerati “rossi”. Nonostante ciò, verso gli ultimi mesi di guerra si avviarono contatti tra partigiani ed alleati. Alcuni militari inglesi, tra i quali Michael Ross, furono salvati [con viaggi via mare verso gli alleati in Costa Azzurra] da mio nonno e da altri partigiani. Nel caso di Ross e dei suoi compagni, fallito il primo tentativo, quando la comitiva giunse finalmente oltre confine, quei partigiani furono salutati come eroi […] Michael Ross fu elevato di grado e divenne un uomo importante nella vita militare inglese. Ancora oggi ogni anno porta a Pasqua una colomba per ringraziare di tutto ciò che i partigiani avevano fatto per lui. Ha anche scritto un libro [From Liguria with love. Capture, imprisonment and escape in wartime Italy, Minerva Press, London, 1997, una fatica letteraria, che riferisce delle rocambolesche vicende di guerra dello scrittore, compresa la fuga da un campo di prigionia a quelle, non ultime per importanza, vissute nella zona ligure di frontiera. Ross sposò, del resto, una delle figlie delle persona che lo tenne nascosto a lungo a Bordighera, Giuseppe Porcheddu]. Thomas Lamberti, ricerca scolastica di fine anni ’90
Ci condusse attraverso il bosco ad una grande villa appena fuori Baiardo. La ragione della sua iniziale apprensione divenne subito chiara. Brunati si era rivelato essere la guida di una banda di sette o otto antifascisti, di età tra i venti ed i trent’anni, che avevano trovato rifugio in quella villa. La proprietaria era Lina Meiffret, la sola donna del gruppo… Brunati… era un generoso, cordiale uomo. Un intellettuale pieno di amore per la letteratura e la poesia… Lina era calma e flemmatica, gentile di natura ma con un forte nucleo di determinazione… Luigi ci portò a Llo di Mare… [Villa in Località Arziglia di Bordighera, in affitto a Giuseppe Porcheddu] Michael Ross, From Liguria with love. Capture, imprisonment and escape in wartime Italy, Minerva Press, London, 1997
Ai primi di novembre [1943] i fuggitivi [Michael Ross e George Bell] giungono in Bagnasco […] Erano giunti in terra ligure senza nemmeno saperlo. Puntarono la mattina più a valle, in vista di un casolare. Ma un incontro del tutto fortuito cambierà i loro progetti, studiati per giorni e giorni. L’uomo incontrato era Renato Brunati e il luogo il paese di Baiardo. […] i Porcheddu liberamente andarono incontro per salvare la vita dei due sconosciuti inglesi. Il ringraziamento, Ross, lo estende a Vincenzo Manuel Gismondi, a Federico Assandria e ad Elio Moraglia. “Beppe aveva ordinato di portarci in una casetta nel paesino di Negi ove vivevano sua moglie e i figli dopo l’arresto di Lina e Brunati” [Ross]. Dopo l’impresa fallita [tentativo di andare in barca a motore da Bordighera per la Corsica, causa affondamento per avaria del natante prescelto!] i due fuggiaschi inglesi riuscirono a trovare riposo e calore umano ma dovettero lasciare le terre di Arziglia […] Don Nino Allaria Olivieri in Ventimiglia … sentieri della speranza <ANPI, Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia, Nante Edizioni, Imperia>, 2006, ripubblicato in Quando fischiava il vento – Episodi di vita civile e partigiana nella Zona Intemelia, Alzani Editore <La Voce Intemelia – A.N.P.I. Sezione di Ventimiglia (IM)>, 2015
La comunicazione alle autorità della RSI in data 15 giugno 1944 della Questura di Imperia – questore Ermanno Durante -, concernente indagini ed arresti di patrioti della zona di Ventimiglia e di Bordighera, edito da Don Nino Allaria Olivieri, Ventimiglia … sentieri della speranza , op. cit., pp. 9-24, riporta: “Biancheri Emilio di Lorenzo, nato a Bordighera, anno 1911, sarto [con attività in Vallecrosia], è altro capo dell’organizzazione. Costui tra l’altro rilevò in Neggi [Negi], frazione del Comune di Perinaldo, due ufficiali inglesi [Ross e Bell] che tentò, a mezzo di un fuoribordo, di portarli in Corsica, senza riuscirvi [nel libro di Michael Ross e nel memoriale di Giuseppe Porcheddu ad andare a Genova a comprare – la relativa spesa venne sostenuta da Piero Giacometti – il motore per quella barca fu Vincenzo Manuel Gismondi]. Con l’aiuto di un certo Renato Brunati, ora in campo di concentramento in Germania [arrestato, invece, una prima volta il 6 gennaio 1944, e catturato in modo definitivo, insieme a Lina Meiffret, a febbraio, subito imprigionato e torturato – al pari della sua compagna di vita e di lotta – nelle carceri di Oneglia, deportato indi a Genova, Marassi, e fucilato dalle SS il 19 maggio 1944 nella strage del Turchino], riuscì a farli andare in Francia. Se si trattava, come di tutta evidenza risulterebbe, di Ross e di Bell, questi due ufficiali britannici solo a marzo 1945, come qui già visto, raggiunsero le file alleate; del resto, l’ing. Elio Riello, già vittima di quella repressione del 23 maggio 1944 e tornato vivo dall’inferno dei campi nazisti, sottolineava a Don Nino Allaria Olivieri, sempre nel lavoro più volte qui citato, circa altri precedenti rapporti repubblichini, che “i verbalizzanti possono aver ad arte dato delle notizie diverse dalla realtà allo scopo di sviare le indagini“, un’impronta fuorviante che potrebbe essere rimasta nelle conclusioni della Questura di Imperia. Adriano Maini
[…] L’operazione più importante alla quale partecipai fu la fuga dei 5 prigionieri alleati che trasportammo in Francia. I 5 soldati erano 2 americani, 2 inglesi e un francese. Gli inglesi erano: Michael Ross, capitano del Welch Regiment; Bell Cecil “George”, tenente della Highland Light Infantry. Il francese era Fernand Guyot, pilota. Gli americani erano i piloti Erickson e Klemme: non ne so né il nome, né il reparto, né altri dettagli, solo che erano piloti. Dopo l’8 settembre 1943 erano fuggiti dai campi di prigionia e avevano vagato per l’Italia settentrionale alla ricerca di un passaggio per la Svizzera o per la Francia liberata. La Resistenza li nascose a Taggia (IM) per qualche tempo, sperando nell’arrivo di un sottomarino per metterli in salvo. Nel febbraio del 1945 il Comando decise di tentare da Vallecrosia. Fui incaricato di prelevare i 5 al solito posto vicino a Negi […] Il tenente inglese Bell continuava a chiedermi quanto tempo mancasse all’arrivo, e io rispondevo sempre “5 minuti”. Seppi poi nel dopoguerra che, nelle sue memorie che annotava nel diario che custodiva gelosamente, mi aveva soprannominato proprio “5 minuti”. Arrivammo a Vallecrosia (IM) dopo mezzanotte [diverse fonti indicano che era il 10 marzo 1945; il tragitto da Negi al mare si era svolto nella notte tra il 9 ed il 10]. Doveva giungere dalla Francia o un sommergibile o il motoscafo di “Caronte” [Giulio “Corsaro” Pedretti] per prelevare gli ex prigionieri. Aspettammo fin quasi all’alba. Non arrivò nessuno. Questo fu un grave imprevisto: un conto è nascondere cinque soldati alleati in montagna, altro è nasconderli in un centro abitato bombardato dagli alleati e sottoposto a continui rastrellamenti. Li nascondemmo a sua insaputa nella casa di Fortunato Lazzati, vicina all’abitazione di Achille […] Fortunato era sfollato a Vallecrosia Alta e aveva sbarrato la porta della sua casa … ma non gli scuri della finestra. Caso volle che Fortunato proprio l’indomani scendesse da Vallecrosia Alta per prendere qualcosa in casa. Sollevato lo sportellino della finestra vide i cinque sconosciuti dormire sul pavimento. Chiuse e scappò non ritornando che a guerra conclusa. Prelevammo un’altra barca dal solito deposito, la predisponemmo alla meglio e la portammo al mare attraverso Via Impero […] Imbarcati i cinque, Enzo Giribaldi e Achille [“Andrea” Lamberti] presero il largo […] … e la barca letteralmente si sfasciò. Udimmo qualche grido di aiuto e ci buttammo a mare per cercare di soccorrerli. Accorsero in acqua anche i bersaglieri, con i quali formammo una catena tenendoci per mano. Non dimenticherò mai quella scena: freddo, mare grosso e in acqua quella catena di bersaglieri con le mantelline che galleggiavano. Sembravano funghi. Soccorremmo i primi, tra i quali uno degli americani che aveva bevuto molto e stava veramente male; Enzo Giribaldi perse anche uno degli stivali che indossava. Mancavano Achille e i due inglesi. Era strano perché Achille era un nuotatore eccezionale. Dopo qualche minuto, apparve con i 2 inglesi che spingeva a turno verso la riva e trascinando il cappotto di uno dei prigionieri. “Tùti in tu belin a mi!“: disse allora Achille. Apprendemmo che l’ufficiale inglese, Bell, non voleva liberarsi del cappotto, malgrado che, quello inzuppandosi, lo trascinasse a fondo, e rendendo ad Achille ancor più faticosa l’opera di salvataggio. Achille glielo tolse quasi con la forza e scagliando tanti accidenti. […] La corrente spinse il relitto della barca fino a Latte [Frazione di Ventimiglia (IM), vicina alla Francia] e la cosa successivamente ci creò non pochi problemi […] I cinque prigionieri furono riportati di nuovo a casa di Fortunato. Si doveva rifocillarli e provvedere loro di vestiti asciutti. Mentre Achille procurava del pane dal forno del partigiano Francesco Cè Bussi, sua madre pensava bene di stendere a asciugare le divise dei soldati alleati sul terrazzo … in bella vista dalla strada! Fortuna volle che, prima di qualche milite fascista, passassi io, che avvisai subito Achille del pericolo […] Giorni dopo recuperammo altre due barche dal solito deposito […] finalmente portammo i battelli al mare e i 7 passeggeri (i 5 alleati e i 2 “passeur”). Prima di partire uno dei “passeur” volle collaudare le barche per verificare che tenesso il mare. Imbarcati tutti, partirono in 9 guidati da Achille e un altro, non ricordo se “Gireu” o Renzo Rossi o altri. Credo Renzo Rossi, che era il capo di tutta l’organizzazione sbarchi. Arrivarono sani e salvi e questa operazione accrebbe non poco la considerazione degli alleati per la Sezione Sbarchi di Vallecrosia. Renato “Plancia” Dorgia in Giuseppe Mac Fiorucci, Op. cit.
I ribelli sono tornati a Calvo
Ventimiglia e la seconda guerra europea. (Appunti Storici dei Fratelli Maristi in Italia – Libro in edizione)
(1943)
A Ventimiglia, nei giorni di generale disorientamento che seguirono l’armistizio dell’8 settembre, avvenne il saccheggio popolare della Caserma Gallardi, nei pressi della nostra casa. Nei fabbricati di questa vasta caserma erano stati ammassati, in seguito alle operazioni di guerra precedenti, ingenti quantità di rifornimenti logistici, particolarmente calzature e indumenti. Molti Fratelli assistettero al parapiglia indescrivibile di una fiumana di gente che durante più di ventiquattro ore correva a prendersi quanta più roba poteva portar via: immagine fedele dell’anarchia e della necessità che regnavano in quei giorni. L’arrivo delle milizie tedesche con le armi in pugno e in mezzo a terribili sparatorie intimidative riuscì a poco a poco a ristabilire l’ordine. Una parte di quelle masserizie fu poi restituita nei giorni seguenti, dietro minaccia di fucilazione.
Aa.Vv., Pennellate storiche sulle Comunità mariste d’Italia e Destinazione annuale dei Fratelli, 1887-2003. Volume 3º, Provincia Marista Mediterránea, Guardamar del Segura – España, 2018
Il 10 di settembre [1943] i futuri dirigenti del Fascio repubblichino di Ventimiglia, Ferdinando Rey, Ugo Ughetto, Elio Piccioni, il generale della milizia Brandimarte ed il commissario di PS Pavone [n.d.r.: responsabile dell’arresto, avvenuto in Ventimiglia il 26 novembre 1943, e della conseguente deportazione in Germania, ad Auschwitz, dove tragicamente perirono, dei commercianti ebrei, Bassi, Ettore, il padre, e Marco, il figlio, benefattori non solo degli ebrei stranieri in fuga, a causa delle Leggi Razziali del 1938, tramite Ventimiglia e zona verso la Francia nel periodo 1938-1939, ma anche benemeriti della città e del comprensorio] richiamavano i tedeschi che, su autocarri, giungevano in città, iniziando una feroce rappresaglia contro tutti coloro che venivano trovati intorno ai magazzini militari […] Già il 10 settembre 1943 a Ventimiglia per loro spontanea iniziativa si erano costituiti in CLN Libero Alborno, Luigi Lorenzi, comunisti, Carlo De Paulis, Domenico Gastaldi, Adriano Notari [n.d.r.: noto medico specialista di Ventimiglia: la sua fama era tale che aveva curato anche il maresciallo Caviglia], rimanendo quasi del tutto isolati nella loro attività. Essi si adoprarono per raccogliere i primi soldati sbandati dell’ex Regio Esercito e convogliarli verso Rocchetta Nervina […] Questo CLN esaurì la sua funzione quando i nazifascisti ordinarono lo sfollamento della città […] bande, anche se disorganizzate, incominciarono a formarsi nelle zone di Calvo, Bevera e Ciotti. Sorte più che altro per sfuggire alla cattura da parte dei tedeschi, si sciolsero in breve tempo. Soltanto a fine maggio 1944 nasceranno le prime bande partigiane […] CLN di Ventimiglia. Quello che operava precariamente anche dopo lo sfollamento generale veniva liquidato il 23 maggio 1944 [n.d.r.: qualche riferimento in più qui e qui] per opera del maggiore della G.N.R. ferroviaria Restituto Aprosio. Dopo di che la mancanza di documentazione rende assai difficile ricostruire quanto è successo. Francesco Biga e Ferruccio Iebole (a cura di Vittorio Detassis), Storia della Resistenza Imperiese (I^ Zona Liguria), Vol. V, Ed. Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia, 2016
A Ventimiglia in ambienti che gravitavano intorno alla stazione ferroviaria si formò una rete clandestina con l’obiettivo di sabotare i trasporti tedeschi e difendere le infrastrutture ferroviarie e stradali in concomitanza di un’eventuale sbarco alleato. A questa organizzazione aderirono una decina di ferrovieri assieme a carabinieri, poliziotti, civili. Il gruppo, che assunse il nome di Giovine Italia, riuscì a collaborare con un’altra organizzazione legata al partito comunista di Bordighera, la quale in clandestinità forniva documenti falsi a militari sbandati e antifascisti ritenuti sovversivi dalle autorità della Repubblica Sociale. Gli ufficiali dell’esercito e i carabinieri che aderirono avrebbero dovuto stabilire il controllo dell’ordine pubblico una volta il territorio fosse stato liberato. A causa di un incauto approccio da parte di Olimpio Muratore, tentato con due suoi compagni di scuola arruolatisi nella GNR ferroviaria, Carlo Calvi e Ermanno Maccario, questi rivelarono l’esistenza dell’organizzazione al loro comandante. Iniziarono subito le indagini portate avanti dalla G.N.R. e dal Commissario Capo della Polizia Repubblicana di Ventimiglia, Pavone. All’alba del 23 maggio 1944 una retata portò alla cattura di una trentina di persone, ventuno delle quali consegnate ai tedeschi, e di queste tredici furono successivamente inviate a Fossoli e poi a Mauthausen: Airaldi Emilio, Aldo Biancheri, Antonio Biancheri, Tommaso Frontero, Stefano Garibaldi, Ernesto Lerzo, Amedeo Mascioli, Olimpio Muratore, Giuseppe Palmero, Ettore Renacci, Elio Riello, Tommaso Frontero, Alessandro Rubini, Silvio Tomasi, Pietro Trucchi e Eraldo Viale. Solamente Elio Riello, Amedeo Mascioli, Aldo e Antonio Biancheri sopravvissero alla deportazione. Emilio Airaldi, invece, già sul carro merci destinato in Germania, riuscì a scardinare un finestrino del carro e a gettarsi di notte nel vuoto nei pressi di Bolzano; venne aiutato da ferrovieri che lo aiutarono s nascondersi e quindi a ritornare a casa dove giunse dopo 3 mesi. Giuseppe Palmero e Ettore Renacci furono fucilati a Fossoli, Olimpio Muratore, Silvio Tomasi, Alessandro Rubini, Eraldo Viale, Ernesto Lerzo e Pietro Trucchi morirono nel campo di Mauthausen.
Giorgio Caudano, Gli eroi sono tutti giovani e belli. I caduti della Lotta di Liberazione. I^ Zona Liguria, ed. in pr., 2020
[ n.d.r.: altri lavori di Giorgio Caudano: Giorgio Caudano, Dal Mare alla Trincea… memorie di uomini, BB Europa, Cuneo, 2019; Silvia Alborno, Gisella Merello, Marco Farotto, Marco Cassini, Giorgio Caudano, Franck Vigliani, curatori della mostra Claude Monet, ritorno in Riviera, catalogo a cura di Aldo Herlaut, Silvana Editoriale, Milano 2019; La Magnifica Invenzione. I pionieri della fotografia in Val Nervia 1865-1925, a cura di Marco Cassini e Giorgio Caudano, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, 2016; Giorgio Caudano, Pigna. Storia di un paese, ed. in pr., 2016 ]
Il 18 corrente, nei pressi di VENTIMIGLIA (IMPERIA) una pattuglia della G.N.R. confinaria catturava una donna, che aveva tentato di espatriare clandestinamente.
Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana (GNR) del giorno 19 maggio 1944, p. 31. Fonte: Fondazione Luigi Micheletti

Imperia – Nella zona di Ventimiglia agisce un’organizzazione clandestina, denominata “G.I.”, dipendente dal partito comunista dell’Italia invasa, che si propone di occupare, al momento opportuno, le caserme, gli uffici postali e telegrafici e le centrali telefoniche, nonché di prendere possesso della ferrovia.
Elementi della G.N.R. hanno già preso contatto con un membro dell’organizzazione, convinto di aver da fare con sovversivi.
Le indagini continuano.
Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana (GNR) del giorno 24 maggio 1944, p. 31. Fonte: Fondazione Luigi Micheletti
In questi giorni, nella zona di VENTIMIGLIA (IMPERIA), in seguito alle indagini svolte dalla G.N.R. per individuare gli appartenenti al “Comitato di liberazione nazionale”, sono stati effettuati 39 arresti di elementi indiziati, compresi i componenti di tre cellule comuniste. L’operazione continua e si sviluppa verso la zona di ponente e nella provincia di CUNEO. Riserva di ulteriori comunicazioni.
Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana (GNR) del giorno 25 maggio 1944, p. 42. Fonte: Fondazione Luigi Micheletti
L’11 corrente, da certo Secondo BOSIO, residente in Ventimiglia, è stato catturato un colombo viaggiatore che portava un messaggio dei ribelli diretto alle autorità militari inglesi.
Si unisce copia del messaggio
Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana (GNR) del giorno 28 maggio 1944, p. 21. Fonte: Fondazione Luigi Micheletti
In montagna, su per giù nel periodo stesso [metà giugno 1944] in cui vi sale Don Micheletto, vi si trasferiscono pure, per entrare fra i partigiani, col consenso e l’appoggio del loro maresciallo, i carabinieri di Ventimiglia, portandosi armi e bagagli.
Il maresciallo, rimasto in Ventimiglia con lo scopo di difenderli, verrà deportato in Germania, sebbene avesse quattro figli ancora piccoli.
La famiglia del maresciallo abitava in Camporosso.
Giovanni Strato, Storia della Resistenza Imperiese (I^ zona Liguria) – Vol. I. La Resistenza nella provincia di Imperia dalle origini a metà giugno 1944, Editrice Liguria, Savona, 1976, ristampa del 2005 a cura dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia
Sebbene, per ora, non si abbiano dati probanti per fare illazioni sullo sviluppo delle operazioni militari sul fronte occidentale, tuttavia allo stato delle cose sembra che la baldanza anglosassone sia stata arrestata a Mentone e ricacciata e costretta a ripiegare.
L’autorità militare germanica, per le necessità contingenti, ha ordinato lo sgombero delle popolazioni della vallata di Ventimiglia, che sono state avviate nei centri di sfollamento a cura delle Federazioni dei Fasci Repubblicani.
Nei giorni scorsi mezzi navali cannoneggiavano Imperia, Ventimiglia, Bordighera, Vallecrosia, causando danni di una certa entità a case di abitazioni private, facendo qualche vittima.
[…] E’ stato catturato a Ventimiglia, dove si era rifugiato, e tradotto a Novi Ligure a disposizione del Tribunale Militare, un agente di P.S. che aveva disertato dall’Ufficio di P.S. di confine di San Dalmazzo di Tenda (Cuneo).
Questore di Imperia, Al capo della Polizia – Vobarno, Relazione mensile sulla situazione economica e politica (mese di settembre 1944), n° di Prot. 013538, Imperia, 1° ottobre 1944 – XII. Documento “MI DGPS DAGR RSI 1943-45 busta n° 4” dell’Archivio Centrale dello Stato di Roma
1944
1° luglio
Stamane Pinuccio è partito per Baiardo, accompagnato da Manetta. Chissà se riuscirà a raggiungere i ribelli ! La settimana scorsa è morto Cassini, il genero di Pepinetu; la morte è stata causata da una mina disseminata nel suo terreno a Grimaldi.
I prigionieri di Airole sono stati liberati, tranne due di cui fino ad ora si ignora la sorte.
2 luglio
Si sentono spesso sganciare bombe non tanto distante da noi. Su tutti i fronti continua l’avanzata degli anglo-americani. I ribelli sono scesi fino a Calvo, ma nessun fastidio hanno dato alla Milizia e nemmeno alla popolazione.
Oggi abbiamo cominciato a vendere il vino a Lire 36 alla bottiglia.
3 luglio
Pinuccio è tornato, si è presentato ieri l’altro, l’hanno subito mandato dietro un mulo e poi la fatalità ha voluto che, assieme ad altri, fossero circondati dai tedeschi e fossero presi prigionieri. Lui però si è scusato dicendo di essere andato a Baiardo a salutare un amico sfollato. Avendo ancora la sua licenza non scaduta, lo hanno lasciato libero. Cercherà egli un’altra via di scampo?
I ribelli sono tornati a Calvo.
[…]
1° agosto
Stamattina sono andata a Ventimiglia per riscuotere il sussidio e ho passato l’intera mattinata nella galleria del Cavo. È stata una giornata di allarmi consecutivi, e dire che non abbiamo ancora visto il bello!
[…]
3 agosto
Dopo una notte di rumore continuo, prodotto dalle zattere e dagli apparecchi, la mattinata è stata abbastanza brutta. Verso le 10, formazioni di apparecchi hanno combattuto con i caccia. Un’infinità di piccole bombe sono state gettate a San Bernardo, Seglia, Peidaigo e Ville. Le più vicine a noi sono cadute da Rocco: 5 di numero. Alle Ville, abbiamo da lamentare una morta, la Magnuna che lavorava da Enrico a raccogliere ceci. Hanno sganciato pure su Bevera con diversi morti anche là. La giornata è proseguita con un ininterrotto rombo di apparecchi che sorvolavano continuamente le nostre teste.
[…]
2 ottobre
Anche oggi sono arrivate parecchie cannonate nei nostri dintorni e siamo stati all’erta quasi tutto il giorno. La notte non c’è stato male, è stata passabile. In Piemattone, da Mascarello, vi è l’incendio, il Butassu e i dintorni sono stati molto battuti.
Caterina Gaggero Viale, Diario di Guerra della Zona Intemelia 1943-45, Edizioni Alzani, Pinerolo, 1988
Agostini Annibale: nato a Genova il 13 maggio 1911, agente in servizio presso la Squadra Antiribelli della Questura di Imperia
Interrogatorio del 10.10.1945: […] Quando i partigiani uccisero in Castelvittorio il parroco Don Padoan, presi parte alla spedizione effettuata dalla squadra in detto paese ove trovammo già sul posto elementi della GNR [Guardia Nazionale Repubblicana]. Fu provveduto all’interrogatorio del sagrestano e non essendo emersi a carico degli abitanti, dopo aver assistito ai funerali del parroco svoltisi a Ventimiglia, facemmo ritorno ad Imperia senza aver fatto nessuna rappresaglia […] Nego di aver assistito all’interrogatorio di elementi comunisti di Ventimiglia, arrestati dal Questore Durante. Nego di aver infierito contro di loro con percosse e sevizie. Mi ricordo che nell’ufficio dove si procedeva al loro interrogatorio entrava un agente che generava fra i colleghi ilarità in quanto portava a braccetto gli arrestati.
[…] Fittipaldi Natale: nato a Ventimiglia il 25 dicembre 1928, squadrista della Brigata Nera “Padoan”
Interrogatorio del 20.6.45: Mio padre fu inviato nel febbraio del 1944 in Germania a lavorare. Rimasi così a Ventimiglia, dove con mia madre e mia sorella vivevo dei proventi del mercato nero fino al novembre del 1944 quando mia madre rimase vittima di un bombardamento navale. Essendo giunto l’ordine di sfollamento, insieme a mia sorella mi recai ad Alassio. Nei primi di gennaio, e precisamente il 10 gennaio, essendo rimasto senza soldi mi arruolai
nella brigata nera di Imperia.
Leonardo Sandri, Processo ai fascisti: una documentazione, Vol. 9 – Liguria: Imperia – Savona – La Spezia, Vol. 9, StreetLib, Milano, 2019
Ventimiglia e la seconda guerra europea. (Appunti Storici dei Fratelli Maristi in Italia – Libro in edizione)
(1944)
[…] In casa si va pensando ai provvedimenti da prendersi per il passaggio della linea del fuoco, giacché si è persuasi che gli alleati, sbarcati a Cannes, passeranno di qua dalle Alpi. Abbiamo sentito radio Londra annunziare che
Ventimiglia è in mano degli alleati giunti già a sette chilometri oltre la città… L’otto settembre [1944], Natività della Madonna, un po’ di calma ci permette la Messa solenne e persino una passeggiatina verso il castello Appio. Ufficiali tedeschi ci avvertono del pericolo che si corre alla vetta. Alcuni fratelli vanno tuttavia a constatare de visu come, dal largo di Latte, le navi alleate hanno sotto il loro controllo tutti i versanti della valle del Latte.
La notte, le batterie del greto della Roia cominciano a sparare maledettamente. Ogni quindici o venti minuti un cannone aggiunge un tal colpo da far sussultare tutta la casa. Al mattino entra in azione anche la marina alleata: i proiettili, con un sibilo caratteristico, rasentano la vetta del monte Magliocca e piombano nella valle verso Bevera. Alle 4.30 tutto il monte è in fiamme. Nella giornata del 9, parecchi son quelli, dei nostri, che non ardiscono fermarsi un momento in casa neppure per pranzare. Durante tutto il pomeriggio l’artiglieria della Roia si mantiene in azione permettendo agli aeroplani nemici di individuarne le precise posizioni.
Aa.Vv., Pennellate storiche sulle Comunità mariste d’Italia e Destinazione annuale dei Fratelli, 1887-2003. Volume 3º, Provincia Marista Mediterránea, Guardamar del Segura – España, 2018

1944
Agosto 1944
VENERDÌ 25 – Bombardamento aereo di Latte e Mortola [Frazioni di ponente di Ventimiglia (IM)]. Prima notte al rifugio (27 persone).

Settembre

MARTEDÌ 5 – Assistiamo, dalla galleria della Mortola, al cannoneggiamento di Mont Agel da parte dell’I.L. Emile Bertin e di 2 C.C.T.T. [I.L. e C.T. abbreviano rispettivamente Incrociatore Leggero e Cacciatorpediniere]
MERCOLEDÌ 6 – Lungo mitragliamento da parte dell’aereo catapultabile su Punta Mortola e Punta Beniamin [località nel ponente di Ventimiglia (IM)]. Giungono i tedeschi nel nostro giardino per impiantare uno scivolo.
GIOVEDÌ 7 – Arrivano gli autocarri tedeschi. Il muro al mare, vicino al terrazzo, alcuni pilastri e il cancello rosa fatti saltare; incomincia la costruzione dello scivolo. Partenza di una parte dei Bargioni.
VENERDÌ 8 – La costruzione dello scivolo rallentata dal mare grosso. Un trattore, per errore, schianta il cancello sulla strada. Posizioni, in Francia, cannoneggiate dall’I.L. Dugay Trouin. Partenza dei rimanenti Bargioni.
SABATO 9 – Primo giorno che andiamo alla casa giù. Un C.T. bombarda Bellenda [altura sovrastante la Frazione, di ponente, Latte di Ventimiglia (IM)]. Conversazione con un tedesco sulle nuove armi. Undici corvette, protette da 2 C.T. e un I.L. cannoneggiano posizioni sopra Ventimiglia e Bordighera.
LUNEDI 11 – Posizioni tedesche sui monti bombardate dalla corazzata Lorraine. Bagno sotto i tiri. Un C.T. bombarda per un’ora Punta Mortola e Punta Arma [località nel ponente di Ventimiglia (IM)].
Diario di guerra, steso da ragazzo, dall’ing. Giuseppe Biancheri, pubblicato su LA VOCE INTEMELIA anno XXXIX n. 10 ottobre 1984, qui ripreso da Cumpagnia d’i Ventemigliusi
Oltre ai partecipanti alla scuola sabotatori, di cui si fa cenno nel resoconto della «Missione Corsaro», furono parecchie decine i Ventimigliesi passati in Francia e incorporati nelle unità alleate. Redazione, Martirio e Resistenza della Città di Ventimiglia nel corso della 2^ Guerra Mondiale, Relazione per il conferimento di una Medaglia d’Oro al Valor Militare, Comune di Ventimiglia (IM), 1971
17 novembre 1944 – Dalla Sezione SIM della IV^ Brigata “E. Guarrini” al comando della IV^ Brigata – Relazione giornaliera
“[…] Ventimiglia: Non esiste quasi più nessuna forza tedesca in detta città, pochi sono anche i fascisti. Da voci della popolazione gli Alleati arriverebbero spesse volte in Ventimiglia Vecchia e paeselli dei dintorni ritirandosi dopo a Latte. Inoltre da notizie non confermate ufficialmente pare che gli Alleati abbiano raggiunto Bevera, San Dalmazzo di Tenda e Briga Marittima. La flotta Alleata bombarda incessantemente la striscia di terra tra San Remo e Ventimiglia. Firmato: Uliano“
da documento IsrecIm in Francesco Biga, Storia della Resistenza Imperiese (I^ Zona Liguria), Vol. III. Da settembre a fine anno 1944, a cura Amministrazione Provinciale di Imperia e patrocinio IsrecIm, Milanostampa Editore – Farigliano, 1977
I soldati tedeschi avevano trasferito la sede del comando del loro distaccamento nella galleria sottostante alla casa.
[…] Nella notte fra l’11 e il 12 dicembre [1944], durante un terribile bombardamento, due proiettili della marina colpirono la casa: uno nella parte superiore del fabbricato centrale, verso il mare; l’altro a pian terreno del fabbricato del noviziato, alla sommità della porta centrale. Lo spavento fu grande, naturalmente; i danni relativamente non molto rilevanti. I Fratelli raddoppiarono di attività per avere dai Tedeschi il permesso di restare nella casa, e vi riuscirono. Riflettendo però su casi già accaduti, in cui cittadini erano stati mandati via sull’istante, i quattro giudicarono miglior partito dividersi in due gruppi: due di loro, si trasferirebbero a Bordighera e due resterebbero in casa; e così fecero […] Ecco il diario delle feste natalizie quale è registrato nel libro degli annali della casa [n.d.r.: il Convento – tuttora esistente, ma ormai abbandonato – dei Frati Maristi è situato in località Santo Stefano di Ventimiglia, due chilometri circa a sud della già citata frazione di Bevera]:
“24 dicembre [1944]: preparativi per la funzione di mezzanotte; nel pomeriggio, forte bombardamento terrestre. Una bomba cade davanti alla falegnameria e rompe tutti i vetri, altre cadono dietro la concimaia. Il C. Fr. Celestino Guyon incamminato per raccogliere dei cavoli corre grave pericolo. Veglia di Natale in compagnia della famiglia Cavandoli. Alle 11,30, come di tradizione, principio della funzione religiosa, col canto dell’invitatorio e del Te Deum laudamus. Poi S. Messa cantata con S. Comunione cui si accostano anche tutti gli assistenti.
25 dicembre [1944]: Natale di sangue! In mattinata, Messa cantata, poi pranzo disturbato da bombardamento terrestre: numerose le bombe cadute nella nostra proprietà e sul pendio verso S. Bernardo.
26 dicembre [1944]: Santo Stefano: festa patronale: Messa cantata. Vi assistono anche i vicini di casa.
29 dicembre [1944]: Arrivo inaspettato del C. Fr. Pancrazio, Direttore e Visitatore, accompagnato dal Fr. Federico Sismondini. Che festa, nel rivederci, dopo tre mesi di spaventi! Si trascorrono insieme gli ultimi giorni dell’anno”.
Il 15 gennaio [1945], s’ingegnarono per improvvisare un carrettino a mano che caricarono di viveri e di vestiario per quattro persone (in previsione dell’espulsione degli altri due); aiutati e accompagnati da un vicino di casa e anche da uno dei due destinati a restare poi in casa, alle sei del mattino, dopo l’ultima messa, durante la quale furono consumate tutte le sacre particole, giacché il Parroco di Bevera era obbligato a partire anche lui, si avviarono verso Bordighera.
Aa.Vv., Pennellate storiche sulle Comunità mariste d’Italia e Destinazione annuale dei Fratelli, 1887-2003. Volume 3º, Provincia Marista Mediterránea, Guardamar del Segura – España, 2018
15 marzo 1945 – Dal comando della V^ Brigata, prot. n° 342, al Comando Operativo della I^ Zona Liguria ed al comando della II^ Divisione – Comunicava che… “il paese di Trucco sul confine italo-francese è presidiato da 30 tedeschi con una batteria antiaerea da 20 mm“…
19 aprile 1945 – Dal comando della Divisione SAP “Giuseppe Mazzini” [di Albenga (SV)], prot. n° 56, al rappresentante dell’Alto Comando Alleato [capitano Bentley] ed al comando della VI^ Divisione “Silvio Bonfante” – Informava che “… Proveniente da Ventimiglia è transitato un treno carico di materiale diretto a Savona…”
22 aprile 1945 – Dal comando della II^ Divisione al Comando Operativo della I^ Zona Liguria – Si chiedevano con urgenza precise disposizioni nei confronti delle truppe liberatrici, che con ogni probabilità saranno Degolliste; le competenze nei confronti del CLN e delle SAP secondo gli accordi intervenuti tra voi e dette organizzazioni… se bisogna portare gradi, in caso positivo quali.
24 aprile 1945 – Dal C.L.N. di Perinaldo (IM) al comando della II^ Divisione – Comunicava che una nostra staffetta ha preso oggi contatto con un piccolo nucleo di degollisti dentro Ventimiglia. Tutta questa zona è tranquilla.
23 aprile 1945 – Dal comando della Divisione SAP “Giuseppe Mazzini” [di Albenga (SV)], prot. n° 60, al rappresentante dell’Alto Comando Alleato [capitano Bentley] – Segnalava… un treno da Ventimiglia per Savona carico di materiale…
da documenti Isrecim in Rocco Fava, La Resistenza nell’Imperiese. Un saggio di regestazione della documentazione inedita dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia (1 gennaio – 30 Aprile 1945) – Tomo II – Tesi di Laurea, Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Pedagogia – Anno Accademico 1998 – 1999
Molti dei Ventimigliesi incorporati nelle unità alleate unitamente a numerosi partigiani parteciparono alla fine marzo 1945 con le truppe alleate alla sanguinosa battaglia dell’Aution, che terminava con la cacciata delle truppe tedesche dal Bacino del Roia…da MARTIRIO E RESISTENZA della Città di Ventimiglia nel corso della 2^ Guerra Mondiale, Op. cit.
La XXXIV divisione Brandenburg, comandata dal generale Theo-Helmut Lieb, era costituta da tre reggimenti (Grenadier-Regiment 80, 107 e 253) e da un reggimento di artiglieria (Artillerie-Regiment 34) <9 ed era schierata da Ventimiglia sulla costa ligure e sulle Alpi marittime fino al Monviso <10. Essa doveva ripiegare dalla Val Roya verso Torino ed aveva incontrato notevoli difficoltà a causa della lunghezza del percorso (si dovevano
oltrepassare il colle di Tenda ed il col di Nava), dei ripetuti attacchi aerei degli Alleati e di quelli dei partigiani, ai quali il 15° Gruppo di armate alleate chiedeva di ostacolare la ritirata tedesca.
[NOTE]
9 Cfr. C. GENTILE, Le forze tedesche di occupazione, cit., pp. 116-117.
10 La divisione, già dal 12 aprile, quando la I divisione France Libre iniziò l’offensiva sulle Alpi Marittime, non era più in grado di mantenere le proprie posizioni nonostante le ingiunzioni di resistere a qualsiasi costo; cfr. ALBERTO TURINETTI DI PRIERO, NOTE su una divisione tedesca in Piemonte. La “5. Gebirgsjaegerdivision” agosto 1944-maggio 1945, in “Notiziario dell’Istituto storico della Resistenza in Cuneo e provincia”, n. 36, dicembre 1989, pp. 193-194.
Ezio Manfredi, Dalle Alpi Occidentali a Santhià. La strage dell’aprile 1945 e la resa del 75° Corpo d’armata, in “l’impegno”, a. XXI, n. 3, dicembre 2001, Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia
Negi era il punto di contatto tra le varie formazioni partigiane che operavano nella zona

Nei giorni che seguirono l’armistizio dell’8 settembre 1943 numerosi soldati sbandati dell’ex Regio Esercito passarono sul territorio del comune di Perinaldo (IM). Ovunque essi vennero accolti ed assistiti dalla popolazione e aiutati nella loro fuga verso casa. Ben quattordici di loro tuttavia furono catturati dai tedeschi e deportati in Germania. I contadini raccolsero le armi da loro abbandonate per consegnarle in seguito ai partigiani… ben sette cittadini di Perinaldo combatterono nel Corpo Italiano di Liberazione (C.I.L.)… Alla fine di settembre 1943 un primo presidio tedesco costituito da un plotone di soldati si stabilì in località Massabò… Nel febbraio 1944 un altro forte presidio di trecento soldati tedeschi si insediò in permanenza nel centro abitato… La Resistenza fu animata da un CLN costituitosi nei primi mesi del 1944 per iniziativa dei tre militanti comunisti Pietro Guglielmi, Guglielmo Guglielmi e Armando Cassini. Le attività di questo Comitato furono volte essenzialmente a raccogliere viveri, denaro e indumenti per i partigiani, oltre al consueto lavoro di propaganda contro i tedeschi e i fascisti e a favore della guerriglia patriottica. Esso ebbe anche parte importante nella costituzione di una banda armata locale nel giugno 1944, banda prima composta da sette e poi da diciassette elementi, comandata inizialmente da Aniello Scarano [alla figura di Scarano, come a quella del dottor Giuseppe Leone, che, benché segretario comunale di Perinaldo, fu attivissimo patriota e collaboratore di Scarano, sono dedicate due ampie relazioni in data 20 maggio 1945, oggi, come si apprende da Biga-Iebole, Op. di cui infra, documenti Isrecim, di Kimi Ivar Oddone, commissario politico della II^ Divisione] e poi da Giobatta Guglielmi fino alla Liberazione. Francesco Biga e Ferruccio Iebole (a cura di Vittorio Detassis), Storia della Resistenza Imperiese (I^ Zona Liguria), Vol. V, Ed. Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia, 2016
… 1944… 20 giugno – …. La scorsa notte, circa 200 uomini, fra richiamati e operai della Todt, hanno preso la via della montagna per raggiungere i ribelli che, oggi, hanno fatto saltare il ponte di Perinaldo. Caterina Gaggero Viale, Diario di Guerra della Zona Intemelia 1943-45, Edizioni Alzani, Pinerolo, 1988

Garibaldini della predetta brigata [V^ Brigata “Luigi Nuvoloni”] distruggono con mine un ponte sulla rotabile Perinaldo-Apricale. Francesco Biga, Storia della Resistenza Imperiese (I^ Zona Liguria), Vol. III. Da settembre a fine anno 1944, a cura Amministrazione Provinciale di Imperia e patrocinio Isrecim, Milanostampa Editore – Farigliano, 1977
Otto giorni dopo [il 27 giugno 1944] Argo [Altorino Iezzoni] moriva in un’operazione a Baiardo (IM). Fu il primo schiaffo che ricevetti dalla realtà della mia guerra di partigiano. Fummo segnati su un grosso registro e arruolati al comando di Vittò [Vitò/Ivano, Giuseppe Vittorio Guglielmo]… Con altri 6 o 7 scendemmo in Alpicella, vicino a Perinaldo (IM), dove c’era un rudere di caserma con i muri perimetrali, ma senza tetto. Qui si radunarono fino a più di 40 partigiani. Per la fame, facevamo da mangiare in una enorme vecchia marmitta, ma avevamo poco o niente da mettere dentro. Decidemmo di andare in una osteria del paese (era di un noto fascista), l’albergo “Da Milano”. Erano i primi di luglio del 1944… Renato “Plancia“ Dorgia in Giuseppe Mac Fiorucci, Gruppo Sbarchi Vallecrosia <ed. Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia – Comune di Vallecrosia (IM) – Provincia di Imperia – Associazione Culturale “Il Ponte” di Vallecrosia (IM) >, 2007

Alla fine di luglio del 1944 dei Distaccamenti della V Brigata garibaldina vennero a stabilirsi nel territorio del Comune e ivi operarono con largo appoggio della popolazione. I loro caposaldi furono le località Negi, Alpicella, Suseneo e un vecchio convento al centro dell’abitato… Una lettera inviata al comandante Vitò, datata 28 settembre 1944 e firmata con lo pseudonimo Vespa, ci informa che a Perinaldo già a partire dal precedente luglio era stato formato un embrione di Giunta Comunale clandestina… Un’importante riunione clandestina avveniva nel pomeriggio dell’8 ottobre 1944 con la presenza di Nuccia [dottor Eugenio Kahnemann di Sanremo (IM)] e Ormea… Francesco Biga e Ferruccio Iebole, Op. cit.
Il 1° settembre [1944] operammo divisi in tre colonne una discesa su Perinaldo. L’azione si svolse fulminea. Giungemmo in paese alle prime luci dell’alba, bloccammo le strade e in pochi minuti eravamo padroni dell’abitato. Per alcuni giorni si rimase a Perinaldo… la popolazione fraternizzava con noi… Ferruccio Ragno Corte in Mario Mascia, L’epopea dell’esercito scalzo, Ed. A.L.I.S., 1946, ristampa del 1975

Ci spostammo a Perinaldo [(IM)] perché là era troppo pericoloso. La stessa notte i tedeschi rastrellarono Seborga e uccisero [era il 9 settembre 1944] il pilota inglese… Eravamo al comando di Cekoff, comandante partigiano che da borghese abitava a Bordighera. I problemi erano tanti e tutti molto seri.
Eravamo 30 partigiani tra cui una ragazza, Sascia [Ada Pilastri, che lasciò su L’epopea dell’esercito scalzo, di Mario Mascia, Ed. ALIS, 1946, ristampa del 1975, una vivida testimonianza delle difficoltà incontrate dai partigiani dell’imperiese per trovare rifornimenti, passando sulle montagne innevate, nel gelido novembre 1944], ma la metà era disarmata. Proposi a Cekoff un piano per recuperare un po’ di armi e ne discutemmo a lungo. Alla fine accettò… Il gelataio Eccolo (Renzo Pirotelli) mi prestò il triciclo fatto a barchetta, con il quale durante l’estate vendeva i gelati sul lungomare di Bordighera e Vallecrosia. Mi procurai anche un attrezzo da scasso e un piccone, depositai tutto nel portone di casa mia e attesi la notte… Piano piano, per fare meno rumore possibile, forzai la porta. Proprio nell’ingresso era in bella mostra la rastrelliera dei fucili con casse di munizioni. Tre alla volta li caricai nel ventre della barchetta e al quindicesimo caricai le scatole di munizioni. Il triciclo era quasi colmo… Pedalai e pedalai con fatica sulla leggera salita per arrivare fino a Massabò, dove mi aspettava Franco Palombi, un amico di Bordighera che mi aiutò a spingere lungo i tornanti per Perinaldo. Senza il suo aiuto non ce l’avrei fatta. Arrivammo stremati in cima alla collina … un urlo di gioia ci accolse. Baci, abbracci e strette di mano. La V^ Brigata partigiana Garibaldi era tutta armata! Angelo Athos Mariani in Giuseppe Mac Fiorucci, Op. cit.
Quando le campane di Bordighera [(IM)] suonarono le 23.00, il 6 gennaio del 1945 il gruppo di sbarco composto dal caporale Mac Dougall, Mimmo [Domenico Dònesi], Nino [Alberto Guglielmi] e me, era riunito su di un battello pneumatico. Avendo ricevuto dalla spiaggia il segnale di via libera, aiutati da Giulio [Giulio Corsaro/Caronte Pedretti, responsabile del gruppo clandestino di partigiani di Ventimiglia, operanti via mare con gli alleati nella Missione Corsaro] con il suo battello, ci dirigemmo verso la riva… A Vallecrosia prendemmo la mulattiera per Negi che raggiungemmo alle 03.30. L’8 gennaio alle 4 lasciammo Negi per salire a Monte Bignone… capitano Robert Bentley in Giuseppe Mac Fiorucci, Op. cit.
… le armi [arrivate via mare a Vallecrosia] venivano avviate in montagna a Negi dove Cekof [o Cecof, Mario Alborno di Bordighera] le riceveva per inoltrarle alle formazioni; distribuite agli uomini di Bordighera o per mezzo di Piero (Angelo Amato), René (Renato Magni) e i Laura delle Sap di Ospedaletti … Mario Mascia, Op. cit.
4 gennaio 1945 – Dal comando del I° Battaglione “Mario Bini”, prot. n° 32, al comando della V^ Brigata “Luigi Nuvoloni” della II^ Divisione “Felice Cascione” – Relazione militare: … a Perinaldo si era portata una squadra di 20 tedeschi per riparare la strada Perinaldo-San Romolo [Frazione di Sanremo (IM)].
12 marzo 1945 – Dal CLN di Sanremo, prot. n° 425, alla Sezione SIM della V^ Brigata – Segnalava che la Brigata Nera il giorno dopo alle 5 avrebbe lasciato Sanremo per dirigersi ad Imperia e e ricongiungersi con altre forze nazifasciste a Perinaldo…
19 aprile 1945 – Dalla sezione SIM [responsabile Brunero, Francesco Bianchi] della V^ Brigata al Comando della I^ Zona Operativa Liguria – Segnalava che… ad Isolabona vi erano 50 tedeschi, ad Apricale 25, a Perinaldo 60-70 ma con alcuni pezzi di artiglieria, che sussistevano lavori in corso nelle postazioni nemiche di Località Alpicella [di Perinaldo] e che sul fronte italo-francese …
20 aprile 1945 – Da “Fedé” al SIM della V^ Brigata – Segnalava che “… Da Perinaldo truppe tedesche d’artiglieria lasciano la zona, forse dirette a Genova…“.
24 aprile 1945 – Dal C.L.N. di Perinaldo al comando della II^ Divisione [Vittò/Ivano Giuseppe Vittorio Guglielmo, comandante] – Scriveva: “Comunichiamo che una nostra staffetta ha preso oggi contatto con un piccolo nucleo di degollisti dentro Ventimiglia. Tutta questa zona è tranquilla“.
da documenti Isrecim in Rocco Fava di Sanremo (IM), “La Resistenza nell’Imperiese. Un saggio di regestazione della documentazione inedita dell’Istituto Storico della Resistenza e della Storia Contemporanea di Imperia (1 gennaio – 30 Aprile 1945)” – Tomo II – Tesi di Laurea, Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Pedagogia – Anno Accademico 1998 – 1999
Negi 1. 5/1945
Egr. Sig. Marchesi
Vi faccio presente che oggi 17 maggio ci sono le votazioni in Perinaldo così che anche la Fraz. Negi é invitata a votare.
Siccome la popolazione é contraria nessuno ha partecipato. Date conferma
Distinti saluti
Il Partigiano VITTORIO
Documento desegretato OSS: il comandante della II^ Divisione Giuseppe Vittorio Guglielmo (Vittò/Ivano) riferiva a Salvatore Marchesi, membro del CLN di Sanremo, del referendum annessionistico indetto dalle truppe francesi che in quel periodo occupavano la zona
La Resistenza a Bordighera (IM): cenni

La propaganda antifascista e antitedesca fu praticata nella zona di Bordighera da Renato Brunati e da me in un contempo indipendentemente, senza che nemmeno ci conoscessimo: ma nel 1940 ci incontrammo e d’impulso associammo i nostri ideali e le nostre azioni, legati come ci trovammo subito anche da interessi intellettuali ed artistici.
La vera azione partigiana s’iniziò dopo il fatale 8 settembre 1943, allorchè Brunati e la sig. Maiffret [n.d.r.: cfr. Sarah Clarke, Lina Meiffret: storia di una partigiana sanremese deportata nei lager nazisti e dei suoi documenti… le vicende di Lina Meiffret e del suo compagno Renato Brunati, attivi militanti della lotta di liberazione dal nazifascismo. Renato Brunati morirà tragicamente fucilato al Turchino nel maggio del ’44. Lina Meiffret conoscerà invece gli orrori del campo di deportazione… L’importante testimonianza, pubblicata sull’organo del PCI sanremese diretto da Italo Calvino… Italinemo] subito dopo l’occupazione tedesca organizzarono un primo nucleo di fedeli e racimolarono per le montagne, sulla frontiera franco-italiana e nei depositi, armi e materiali: armi e materiali che essi vennero via via accumulando a Bajardo in una proprietà della Maiffret, che servì poi sempre di quartier generale in altura, mentre alla costa il luogo di ritrovo e smistamento si stabiliva in casa mia ad Arziglia e proprio sulla via Aurelia. Nei giorni piovosi di settembre ed ottobre 1943 i trasporti d’armi e munizioni, furon particolarmente gravosi: occorreva (ai due capi) far lunghissimi rigiri per evitar le pattuglie ed i curiosi, sempre pronti alle indiscrezioni e delazioni: così i nostri patrioti conobbero a fondo l’asprezza e le insidie della zona Negi, Monte Caggio, Bajardo […] L’armamento della banda, ormai numerosa di circa 40 elementi, raggiunse i 30 moschetti e le 5 mitragliatrici, più bombe a profusione e forti riserve di munizioni. Verso la metà di novembre [1943] due ufficiali inglesi, fuggiaschi del campo di ferma vennero a capitar nella zona di Bajardo, ricoverati e confortati dai nostri, sistemati poi nottetempo in un casolare di vetta […] Purtroppo il 14 febbraio 1944 Brunati e la Maiffret, venivano definitivamente presi dai repubblicani, su denuncia di (……) Garzo partigiano traditore, ex camicia nera rientrato nella guardia repubblicana per inimicizia coi 2 eroici capi: la denuncia era tale da comportar pronta esecuzione capitale, ma l’intervento d’un agente bene intenzionato, faceva sospender le condanne e vi sarebbe riuscito del tutto se il console Bussi vigliaccamente non avesse distratto le pezze a scarico, consegnando i 2 capi alla S.S. tedesca. Sappiamo dolorosamente che Brunati e la Maiffret vennero bestialmente seviziati: il 1° fu poi fucilato il … maggio a … la seconda deportata in Germania ove languì per 10 mesi: ora essa è salva, il che ha del miracoloso. Io fui nell’ottobre ’43 interessato dal dott. Ronga di S. Remo a formare in Bordighera il Comitato di liberazione e più tardi, per incarico del noto cap. Gino [Luigi Punzi], iniziai i collegamenti col defunto gen. Pognisi, con il rev. Don Pellorese ed il dott. Marchesi [Salvatore Marchesi, Salibra, partecipe, come il citato dott. Ronga, del primo gruppo patriottico di Sanremo, connotato anche con i nomi di battaglia “Turi” e “Salvamar”, chimico, in seguito ispettore circondariale del CLN di Sanremo (IM) per la zona Bordighera Ventimiglia, fratello del prof. Concetto Marchesi, quest’ultimo, come noto, un insigne latinista, a sua volta impegnato nella Resistenza a livello nazionale], ma per la morte del 1° e la non continua permanenza del 2° l’organizzazione restò imperfetta. Più tardi il dott. Marchesi, raccolte le fila di vari gruppi mi sollecitò nuovamente a costituire un nuovo comitato, ma la presenza in casa mia dei 2 ufficiali inglesi pur consentendomi i collegamenti con ufficiali del S.I.M. e di partigiani, non mi permetteva d’assumere posizioni ufficiali: avevo promesso a Brunati ed alla Maiffret di portare in salvo ad ogni costo i 2 alleati. Il cap. Gino ufficiale di collegamento cogli alleati e più volte sbarcato ad Arziglia aveva prescelto la mia casa per l’installazione radio trasmittente onde riferire oltre frontiera; 2 giorni prima del suo ritorno con gli apparecchi veniva ucciso da un colpo di scure vibratogli a tradimento da un marinaio rinnegato. Nel gennaio 1945 la Signora Marchesi, moglie del capo comunista Concetto Marchesi, e la figlia sposata Mendelssohn con un ebreo americano, venivano ricoverate in casa mia coll’aiuto del dott. Marchesi, fratello di Concetto; esse sottostavano alla taglia di 1 milione, già applicata a Concetto Marchesi; fuggito questo in Svizzera le sue familiari rilevarono il funesto privilegio. Esse restarono in casa mia 25 giorni mentre ivi albergavano pure i 2 ufficiali inglesi; la prudenza e infinite cautele oltre al volere degli ospiti stranieri ci obbligarono ad occultare la presenza di questi alle signore Marchesi: e ci riuscimmo. Il 24 gennaio il dott. Marchesi precipitatosi in casa mia comunicò che i tedeschi dovevan partire entro 2 giorni, prelevando tutti i designati ostaggi di cui io risultai capolista. Si impose una fuga generale; Marchesi collocò altrove cognata e nipote, noi ci rifugiammo nella villa di Kurt Hermann… nazista, naturalmente a sua insaputa: i 2 ufficiali inglesi, guidati da mio figlio pei monti, di notte, raggiunsero rifugi ignoti, mentre mio figlio scendeva la costa in attesa degli avvenimenti. La notizia dataci risultò imprecisa, chè la fuga tedesca tardò ancora 3 mesi. Ma i 2 inglesi dopo romanzesche avventure in montagna e sulla costa di Vallecrosia raggiunsero la Francia e si misero finalmente al sicuro. Giuseppe Porcheddu, manoscritto (documento Isrecim) edito in Francesco Mocci (con il contributo di Dario Canavese di Ventimiglia), Il capitano Gino Punzi, alpino e partigiano, Alzani Editore, Pinerolo (TO), 2019
Alipio Amalberti, figura storica dell’antifascismo del Ponente ligure, già nei primi giorni seguenti l’8 settembre mette in piedi un’organizzazione per finanziare ed armare i gruppi che si stanno formando in montagna insieme a Renato Brunati e Lina Meiffret. Preso come ostaggio, in quanto segnalato più volte come sovversivo, viene fucilato a Badalucco, come ritorsione ad un’azione del distaccamento di “Artù”, Arturo Secondo, compiuta il 31 maggio, il 6 giugno 1944.
Giorgio Caudano [ n.d.r.: tra le pubblicazioni di Giorgio Caudano: Giorgio Caudano, Dal Mare alla Trincea… memorie di uomini, BB Europa, Cuneo, 2019; Silvia Alborno, Gisella Merello, Marco Farotto, Marco Cassini, Giorgio Caudano, Franck Vigliani, curatori della mostra Claude Monet, ritorno in Riviera, catalogo a cura di Aldo Herlaut, Silvana Editoriale, Milano 2019; La Magnifica Invenzione. I pionieri della fotografia in Val Nervia 1865-1925, a cura di Marco Cassini e Giorgio Caudano, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, 2016; Giorgio Caudano, Pigna. Storia di un paese, ed. in pr., 2016 ]
Le prime voci di antifascismo a Vallecrosia si ebbero nel 1940/41 da parte di Achille [Achille Lamberti, “Andrea”], di Francesco “Cè” Garini, di “Girò” [n.d.r.: o “Gireu”, Pietro Gerolamo Marcenaro], di Aldo Lotti e di altri.
Un antifascismo molto riservato, anche perché le ritorsioni erano molto dure, come nel caso di Alipio Amalberti, zio materno di Girò, che per aver gridato in un bar di Vallecrosia “Viva la Francia” venne dapprima schedato e successivamente costantemente perseguitato, fino a essere fucilato per ritorsione dopo essere stato preso come ostaggio.
Renato “Plancia“ Dorgia in Giuseppe Mac Fiorucci, Gruppo Sbarchi Vallecrosia, ed. Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia < Comune di Vallecrosia (IM) – Provincia di Imperia – Associazione Culturale “Il Ponte” di Vallecrosia (IM)>, 2017

Una vista da Bordighera su Vallecrosia e Costa Azzurra
… il generale Cesare Rossi, che in Bordighera aveva allora la sua residenza. Mario Zino e il Caldani, in seguito ad una lettera del 2 gennaio 1944, inviata da Ferruccio Parri… erano venuti appositamente da Genova a Bordighera, dietro indicazione del generale Panizzi, anch’egli aderente alla Resistenza… Il generale Rossi aderì alle proposte… ma si trasferì nella sua casa di Genova… entrerà poi a fare parte del Comando militare del CLN regionale… infine arrestato dai nazifascisti il 4 gennaio 1945… e morrà il 24 aprile 1945, mentre incatenato con altri… è dai tedeschi fuggiaschi trasportato verso l’interno della pianura padana.
Giovanni Strato, Storia della Resistenza Imperiese (I^ zona Liguria) – Vol. I. La Resistenza nella provincia di Imperia dalle origini a metà giugno 1944, Editrice Liguria, Savona, 1976, ristampa del 2005 a cura dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia

Una vista su Vallecrosia e Bordighera
Imperia
Il 1° corrente, in Bordighera e San Remo, vennero rinvenuti manifestini stampati a ciclostile e firmati “Comitato sindacale segreto provinciale e gruppi di difesa della donna per l’assistenza ai combattenti della libertà”, invitanti le masse lavoratrici allo sciopero generale.
Il 1° corrente, in Vallecrosia, furono rinvenuti affissi ai muri manifestini incitanti gli operai allo sciopero.
Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 10 marzo 1944, p. 6, Fondazione Luigi Micheletti
Nei primi mesi della lotta di liberazione si era anche formato un gruppo partigiano "Giustizia e Libertà", ossia del Partito d'Azione: era comandato dal capitano Umberto (Candido Bertassi) e in un certo momento giunse ad avere anche 200 uomini. Operava fra Bordighera e Sanremo, sulla fascia collinare e montana in prossimità della costa. In seguito, verso la fine dell'ottobre '44 e i primi di novembre, fu per qualche tempo alle dipendenze del CLN circondariale sanremese. "Si sciolse dopo il rastrellamento di San Romolo" (14 novembre 1944); ed i sui uomini "in parte passarono alle formazioni garibaldine, in parte si misero a disposizione del CLN di Sanremo, in parte si sbandarono". <49 49 Note ricavate da "L'epopea dell'esercito scalzo, Mascia, pag. 204. Sentite pure varie persone. Giovanni Strato, Storia della Resistenza Imperiese (I^ zona Liguria) - Vol. I. La Resistenza nella provincia di Imperia dalle origini a metà giugno 1944, Editrice Liguria, Savona, 1976, ristampa del 2005 a cura dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Imperia
Anche Ventimiglia ha i suoi dolorosi ricordi: Alessandro Rubini, capostazione: carceri d’Oneglia, di Marassi, campo di Fossoli, di Bolzano e poi di Mauthausen; infine la morte il 17 dicembre 1944.
Il manovale Giuseppe Palmero, invece, non ebbe tempo per i trasferimenti ed a Fossoli morì.
A Bordighera il capitano Silvio Tomasi ed il tenente Giovanni Garibaldi toccarono Fossoli, anch’essi provenienti da Marassi. Anche per questi due patrioti il maledetto campo non rappresentò che una sosta prima di Mauthausen ed il sacrificio supremo.
Ettore Renacci, Tommaso Frontero e Angelo Schiva facevano parte di un gruppo comunista formatosi già all’inizio del 1943 in Bordighera. Nel dicembre dello stesso anno, tale gruppo assunse la denominazione di «Comitato Comunista di Settore» e si unì ad elementi di altre correnti e partiti antifascisti. In seguito all’attività comune fu creato il CLN di Bordighera per la lotta resistenziale, ma la rete clandestina venne scoperta e sgominata. Frontero e Renacci furono arrestati nelle rispettive abitazioni verso le 8 del 23 maggio 1944. Subirono maltrattamenti e furono condotti a Imperia: se ne decise la fucilazione per il 25 maggio. Ma la Gestapo li considerava elementi troppo preziosi e cercò di indurli a rivelare notizie utili sull’organizzazione antifascista. Frontero e Renacci raggiunsero quindi le carceri di Marassi e, nel giugno, fecero parte di un gruppo di 59 prigionieri trasferiti da Genova a Fossoli per mezzo di camion. A Fossoli il Renacci venne fucilato ed il Frontero inviato nei Lager in Germania. Carlo Rubaudo, Storia della Resistenza Imperiese (I Zona Liguria) – Vol. II. Da giugno ad agosto 1944, edito a cura dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia, Imperia, Dominici Editore, 1992
È noto, altresì, che, sotto la stessa data [22 gennaio 1945] l’Ufficio di Polizia di Ospedaletti si trasferiva a Bordighera. Il provvedimento è stato preso in dipendenza dell’importanza assunta da quel Comune per effetto dell’aumento della popolazione dovuto al continuo affluire di sfollati dalle località viciniori e comune di Ventimiglia.
Sergiacomi, Questore di Imperia, Al capo della Polizia – Sede di campagna (visto di arrivo del Ministero dell’Interno della RSI in data 7 marzo 1945), Relazione mensile sulla situazione politica, militare ed economica della Provincia di Imperia, 1 febbraio 1945. Documento in Archivio Centrale dello Stato a Roma
I fratelli Biancheri favorirono l’incontro di Bertelli con il dottore Salvatore Turi Salibra/Salvamar Marchesi, membro di rilievo della Resistenza, ispettore circondariale del CLN di Sanremo per la zona Bordighera-Ventimiglia, fratello del prof. Concetto Marchesi, quest’ultimo, come noto, un insigne latinista, a sua volta impegnato nella Resistenza a livello nazionale. Gli incontri con il dottore Marchesi avvenivano in un albergo sito sulla Via Romana a Bordighera (IM), dove, tra l’altro, Bertelli collaborò alla stesura di alcuni volantini inneggianti alla fine della guerra ed esortanti alla diserzione, che furono clandestinamente lasciati nei locali e nei luoghi frequentati dalle truppe. Con la collaborazione del sergente Bertelli, quando egli ed i suoi uomini erano di servizio a Vallecrosia, poterono realizzarsi diversi collegamenti clandestini via mare da e per la Francia liberata, effettuati dal Gruppo Sbarchi di Vallecrosia. Il sergente Bertelli cercò inutilmente sul finire della guerra di dissuadere i fratelli Biancheri dal voler raggiungere i famigliari a Bordighera: i fratelli Biancheri furono catturati durante un rastrellamento e successivamente passati per le armi a Ventimiglia, in zona Forte San Paolo. Giuseppe Mac Fiorucci, Gruppo Sbarchi Vallecrosia, ed. Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia < Comune di Vallecrosia (IM) – Provincia di Imperia – Associazione Culturale “Il Ponte” di Vallecrosia (IM) >, 2007
Salvatore Marchesi, dottore in chimica e ammogliato, già combattente nella prima guerra mondiale, fu alla direzione degli sbarchi clandestini nella zona di Bordighera durante la Resistenza, fratello di Concetto Marchesi, il professore grande umanista e latinista, rettore dell’Università di Padova, il quale invitò i giovani studenti, durante l’apertura dell’anno di studio 1943 – 1944, a salire in montagna per combattere per la libertà.
Francesco Biga, Ufficiali e soldati del Regio Esercito nella Resistenza imperiese in Atti del Convegno storico LE FORZE ARMATE NELLA RESISTENZA di venerdì 14 maggio 2004, organizzato a Savona, Sala Consiliare della Provincia, da Isrec, Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della provincia di Savona (a cura di Mario Lorenzo Paggi e Fiorentina Lertora)
Tra questi martiri, Paolo Biancheri (Paolo), nato a Bordighera, e i due fratelli Biancheri, detti Lilò, Bartolomeo ed Ettore, patrioti del Gruppo Sbarchi di Vallecrosia. Un documento d’epoca indirizzato al CLN di Bordighera, oggi conservato a Sanremo, ricorda che essi vennero fucilati insieme a Paolo Balbo (Pietro), Adolfo Piuri (Stella), Giuseppe Rosso (Pierino), Emilio Sasso (Puma) e Giuseppe Verrando (Mil).
Rocco Fava di Sanremo (IM), La Resistenza nell’Imperiese. Un saggio di regestazione della documentazione inedita dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia (1 gennaio – 30 Aprile 1945) – Tomo I, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Trieste, Anno Accademico 1998 – 1999
11 febbraio 1945 – COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE SANREMO S.I.M. [Servizio Informazioni Militari] prot. n° 276 – Oggetto: informazioni sui risultati dei bombardamenti alleati. Alla Sezione S.I.M. della V^ Brigata Z.O. – p.c. Ispettorato Militare I^ Zona Z.O. e Delegazione di zona militare Imperia – Vi preghiamo di comunicare al cap. Roberto [capitano Robert Bentley del SOE britannico, ufficiale di collegamento degli alleati presso i partigiani della I^ Zona Operativa Liguria] i risultati degli ultimi bombardamenti aereo-navali alleati nella zona di nostra competenza: … BORDIGHERA: martedì 6 febbraio = bombardamento aereo: le bombe sono cadute nei pressi del municipio uccidendo tre persone. Nessun obiettivo militare colpito. mercoledì 7 febbraio = bombardamento aereo = le bombe sono cadute a circa 8 metri dall’ospedale = 1 persona uccisa = obiettivo militare più vicino: radio goniometro a circa 400 metri di distanza. Con riserva di ulteriori comunicazioni. Fraterni saluti. C.LN. = SANREMO il responsabile del SIM (Mimosa) [Emilio Mascia]

17 marzo 1945 – Dalla Sezione SIM della V^ Brigata “Luigi Nuvoloni“, prot. n° 344, al Comando Operativo [comandante Nino “Curto” Siccardi] della I^ Zona Liguria ed al comando della II^ Divisione “Felice Cascione” [comandante Giuseppe Vittorio ‘Vittò/Ivano‘ Guglielmo] – Riferiva che “… A Bordighera continua il bombardamento della città“.
da documenti IsrecIm in Rocco Fava di Sanremo (IM), La Resistenza nell’Imperiese. Un saggio di regestazione della documentazione inedita dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia (1 gennaio – 30 Aprile 1945) – Tomo I, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Trieste, Anno Accademico 1998-1999

Giovanni Olivo di Matteo ed Eleonora Magaglio; nato il 18 Novembre 1923 a Bordighera (IM). Militò nella V brigata della Divisione ‘Felice Cascione’ Liguria. Fucilato a Pieve di Teco (IM).
Riconosciuto partigiano dal 27 Luglio 1944 al 2 Marzo 1945.
Fu insignito del titolo di “Dottore Honoris Causa” in Scienze Agrarie dall’Università di Bologna.
E’ ricordato nel Sacrario di Piazza Nettuno.
Redazione, Giovanni Olivo, Storia e Memoria di Bologna
Come era stato segnalato, nelle prime ore del 2 marzo 1945, una colonna tedesca di circa seicento uomini, entra nella Valle Pennavaira attraverso il passo di Caprauna. Le pattuglie partigiane avvistano il nemico per cui mettono in stato d’allarme la zona. In breve tempo il personale dell’intendenza nasconde i viveri, ma non si può evitare che due garibaldini, il russo Andrivich e “Alpino”, siano catturati dal nemico in seguito ad un breve ma duro combattimento. Questi sfoga la sua ira contro la popolazione civile, è uccisa una donna che aveva aiutato i partigiani. I Distaccamenti riescono a sottrarsi allo scontro per la scarsissima dotazione di armi automatiche e di munizioni. Lagorio Enrico (Enrico) e Giovanni Olivo (Gianni), altri due partigiani catturati, sono condotti a Pieve di Teco ed ivi fucilati.
Francesco Biga, (con la collaborazione di Osvaldo Contestabile), Storia della Resistenza Imperiese (I^ Zona Liguria), Vol. IV: Da Gennaio 1945 alla Liberazione, ed. Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia, 2005, p. 192
Per la prima volta parlo pubblicamente di mio fratello Giovanni Olivo, eroe della Resistenza. Lo faccio con pudore, perché nessuna parola è efficace per esprimere il senso della sua grande e breve esistenza. Giovanni aveva 21 anni quando il 2 Marzo 1945, fucilato dai tedeschi a Pieve di Teco, donò la propria vita per un grande ideale. A me non fu concessa la gioia della condivisione come sorella: ci ha separato la differenza di età. Infatti avevo dieci anni quando lui, studente in medicina all’Università di Bologna, si rifugiò a Rezzo, dove aderì alla lotta partigiana, donando la propria giovinezza. Il suo nome è inciso sui Cippi che ricordano tutti i caduti: Arezzo, Pieve di Teco, Imperia e Bordighera.
La sua assenza-presenza è incisa nel mio cuore. La sua testimonianza è stata per me un faro di luce nei momenti in cui la vita mi ha dato modo di svolgere ruoli delicati, prima come insegnante ed educatrice, in seguito nel ruolo delicatissimo di pubblico amministratore, quale Sindaco della nostra amata Bordighera.
Ho accettato e affrontato situazioni impegnative, spesso laceranti, guardando a Lui, a mio fratello Giovanni, che offrì se stesso perché altri avessero la Vita. Ho voluto che da Rezzo, dove era stato tumulato dopo la sua morte, ritornasse a Bordighera, rispettando il desiderio dei nostri genitori.
E tornò in un giorno speciale: il 14 Maggio 1996, festività di S. Ampelio […]
Renata Olivo in Paize Autu, Periodico dell’Associazione “U Risveiu Burdigotu”, Anno 7, nr. 4, Aprile 2014
… Il Comune di Bordighera ebbe complessivamente 25 caduti partigiani… Moscone [Basilio Mosconi, comandante del II° Battaglione “Marco Dino Rossi” della V^ Brigata “Luigi Nuvoloni” della II^ Divisione “Felice Cascione”] con il suo reparto occupa Bordighera il 25 aprile 1945. La situazione non era brillante. I francesi (per lo più con truppe senegalesi), che erano avanzati con gli inglesi dai fortini di confine, pretendevano di occupare la zona occidentale della Riviera dei Fiori sino a Sanremo e minacciavano rappresaglie. Dovettero intervenire le autorità del C.L.N. [circondariale di Sanremo (IM)] e americane per definire dei confini provvisori… don Ermando Micheletto, Op. cit.


[ Altri partigiani e patrioti di Bordighera (IM), caduti su vari fronti: BERSIA TERESIO, NATO IL 29/11/1921 A BORDIGHERA, DECEDUTO IL 15/1/1945, sepolto nel CIMITERO MILITARE ITALIANO D’ONORE DI MONACO DI BAVIERA, come da ricerca di ROBERTO ZAMBONI su Dimenticati di Stato – BIANCHERI MULLER GIULIO – CATELANI FLAMINIO – COSTAMAGNA FRANCESCO – FOCA FRANCESCO – MANASSERO CARMEN – MANASSERO GIOCONDA – MIRAGLIO FELICE – MIRANDA ABDON – MORETTA GIUSEPPE – OLIVA GIOVANNI – OLIVIERI CARLO – OLIVO GIOVANNI – PALLANCA LUIGI – POGGI ENRICO – RAINERI GIACOMO – RAMELLA ENRICO – SCARPARI RICCARDO – VERRANDO VINCENZO – ZAMBONI EMILIO ]